Storia
PAZZI ‘E VICIENZO / Gemito e Verdi: incontro di geni, tra necessità e passione

Vi proponiamo il secondo di una serie di articoli per raccontarvi alcuni episodi della vita e dell’arte di Vincenzo Gemito al quale Identità Insorgenti dedicherà il suo prossimo lavoro video, che sarà presentato nel 2019, le cui riprese sono iniziate nei giorni scorsi tra Palazzo Zevallos e Capodimonte (e altri spazi museali e storici nelle prossime settimane). Nel 2019 a Parigi è prevista la monumentale mostra dedicata all’artista: il direttore di Capodimonte, Bellenger, è nel comitato scientifico. Il primo lo abbiamo dedicato all’Acquaiolo per Francesco II e potete leggerlo qui.
La statua di Giuseppe Verdi, con il capo lievemente chino e lo sguardo compenetrato di chi è nel pieno dell’ispirazione, la potete ammirare, a Napoli, al Museo di Capodimonte nella collezione di Achille Minozzi, il mecenate che raccolse la maggior parte delle opere dello scultore (il fondo Minozzi è interamente ospitato in tre sale del Museo). O anche a Palazzo Zevallos. Ma il pezzo di creta modellato dalle mani di Gemito di cui raccontano i grandi scrittori dell’epoca, è all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che pure conserva gli originali in terracotta di Morelli e di Ernest Meissonier.
Indice
L’incontro raccontato da Di Giacomo
Tra gli incontri storici del nostro amato, c’è sicuramente quello con Verdi, che Salvatore Di Giacomo, nella biografia dedicata a Gemito descrive così: “Nel tempo in cui verdi rimase a Napoli per badare alla rappresentazione del Don Carlos e dell’Aida – 1872-73 – conobbe Gemito per l’affettuosa intromissione del Morelli. Lo scultore, chiamato in quell’anno dalle iscrizioni di leva, avrebbe ben presto dovuto lasciare la stecca per fucile. Bisognava impedirlo. E come di que tempi v’era ancora l’abito del cambio (si poteva cioé scansare il servizio militare, pagando, ndr) si pensò subito ad esso e al denaro che occorreva per sostituire Gemito nell’esercito. Fu raccolta una somma ma non bastava. Morelli indusse Verdi a commettere un suo ritrattò per Gemito. Verdi acconsentì: posò per Gemito all’Hotel Crocelle (in Via Chiatamone, ndr) e lì per non più di quattro o cinque giorni si recò lo scultore. E lì si infiammò davvero la creta sotto le sue mani e palpitò l’animo anelante del genio. Lo stile e la fattura del busto di Verdi – osserva ancora Di Giacomo – sono analoghi a quelli dei ritratti di Morelli e Mariano Fortuny: quei tre busti hanno il medesimo valore di grandezza ed effetti. Ed è il momento in cui Gemito più intensamente ferma nella creta la sua impressione pittorica e comunica allo spettatore con virtù immediata quel medesimo soprassalto, ond’egli è stato colto da somiglianti visioni imperiose. Non si parlò in quelli anni se non di quelle mirabili plastiche. E quel giovanissimo artista, fiero della sua gloria indiscussa, parve all’improvviso uno di quegli spiriti dominatori fatti per cavare dall’umanità falangi di immagini imponenti”.
L’incontro secondo Ottavio Morisani
Pur se sotto certi aspetti illuminante, stranamente Di Giacomo pecca in alcuni passaggi della biografia di Gemito di superficialità. Perché la storia dell’incontro tra Gemito, allora 19enne, e Verdi, 59enne, è molto più intensa e complessa e la racconta con dovizia di particolari, anche emozionanti, Ottavio Morisani in “Vita di Gemito”. Alla storia dedica addirittura un intero capitolo. E racconta che Morelli dovette insistere molto con Verdi che “non volea dapprima sentirne parlare, schivo com’era di popolarità e di ostentazione, sembrandogli quasi, col farsi ritrarre in bronzo, di ricever lodi che non gli fosser dovute. Morelli insistette con tanto buon garbo che egli si arrese, ma controvoglia, e posà, con piglio duro, distante e forzato”.
L’incontro tra i due Morisani lo racconta così: “Gemito (ce lo dipinge D’Annunzio) era giunto da un giardino presso il Reclusorio (vicino al Museo Archeologico, ndr) dove lavorava spesso, disordinato, con un gran masso di creta sulle spalle ed avea posto il suo trespolo nell’albergo Crocelle, dove abitava il maestro. Le sedute di posa incominciarono, prolungandosi senza che si venisse a capo di nulla. Verdi posava senza volontò e lo scultore si gingillava con la creta, senza tracciare una linea fissa, attardandosi in qualche dettaglio dell’abbozzo informe o in qualche disegno preparatorio: l’uno non aveva voglia e l’altro, non che non provasse, ma non lo tentava neppure. Era un’opera svogliata che stancava entrambi… perché l’uno, forse, non credeva nel talento dell’altro e l’altro ingorava qual fosse il genio dell’uno: si sfuggivano come due forze nemiche”.
Accadde però che Gemito – mai stato prima a vedere un’opera lirica – va al San Carlo a vedere l’Aida e “si appassiona alle scene, alle architetture false di cartone ai personaggi gravi che prendono sul serio se stessi” senza capire nulla di quanto accade sulla scena. “Ma quando la marcia trionfale anima la scena di personaggi, il ragazzo non ancora addormentato in lui si risveglia. Un entusiasmo lo prende che è quello di tutti i fanciulli di fronte a uno spettacolo variato” racconta Morisani. E sulle sedie del San Carlo Gemito pare abbia trovato finalmente l’ispirazione.
“L’indomani mattina, inquieto, agitato, con gli occhi gonfi d’insonnia, ansioso di vedere quanta povera sia la propria creta di fronte all’uragano che quella notte lo ha scosso, Gemito si avvia all’albergo Crocelle, radendo le mura, quasi sentendosi in colpa. Ed entra inosservato. Per le scale lo colpisce il suono di un pianoforte: sale sempre più lentamente; apre l’uscio, silenzioso. Innanzi allo strumento, Verdi suona a capo chino uno dei motivi dell’Aida. Lo scultore rimane inchiodato sulla soglia da una forza improvvisa e invincibile, sentendosi vuoto, inerte, non osando guardare il trespolo dimenticato in un angolo e su cui binacheggia il panno umido posto a coprire la creta – racconta Morisani – Il maestro lo scorge finalmente, s’arresta, vuole alzarsi. Allora, con voce non più umana, che gli esce a forza dalla strozza serrata, l’altro grida: “No! No! Maestro! Suonate! Ed è tale il lamo degli occhi, è così imperioso l’accento, che Verdi comprende e, chinato di nuovo il capo, riprende a inseguir sulla tastiera i propri sogni. Questo gesto libera Gemito da una pastoia. Balza al trespolo, scopre l’abbozzo informe e quasi bevendo con gli occhi l’immagine dell’altro, senza guardar quello che le mani eseguono, visionario di una conquista, impone il proprio pollice alla materia”.
Nell’ode ai giovani il racconto di Gabriele D’Annunzio
Invece la più poetica narrazione dell’incontro tra Gemito e Verdi è di Gabriele D’Annunzio. La narra nell’ode ai giovani che fu pubblicata insieme ai suoi versi in morte di Verdi.
“Il Maestro – scrive D’Annunzio – già quasi sessantenne, toccava l’apice della gloria terrena. Nell’età in cui l’interno sole impallidisce e tramonta, egli aveva rischiarato il cielo dell’arte con una di quelle illuminazioni repentine che hanno la novità e la magnificenza delle aurore. Nell’età in cui l’anima si volge a riguardare in dietro, quando l’artefice stanco versa nelle usate impronte una materia affievolita, egli aveva dato della sua facoltà di rinnovarsi una stupenda testimonianza in un’opera vasta dove la passione la vittoria la voluttà e la morte si rivelano con un impeto lirico inaudito. A traverso i mari, a traverso i continenti, il delirio delle moltitudini saliva verso di lui come quell’igneo vento libico che si parte dalla terra natale de’ suoi eroi. Egli chinava il capo, solitario e meditabondo.
Ora, a Napoli, dov’egli faceva soggiorno, fioriva un giovinetto meraviglioso che pareva nato veramente d’una di quelle antiche stirpi migranti dall’Ellade alle rive della Campania su navi condotte dal notturno suono dei cembali di bronzo. Il vigore ingenuo della più bella primavera ellenica scorreva nelle sue membra, ardeva nei suoi grandi occhi neri sottilmente venati di sangue come quelli dei cavalli generosi. Tale doveva essere il figliuolo di Carmide, escito di puerizia, quando sotto l’insegnamento di Agelada si preparava a celebrare gli alti fatti delle guerre mediche nel metallo prodotto dalla decima prelevata sul bottino di Maratona.
Sul Golfo, alla presenza perpetua del Mare, in un paese di lineamenti armoniosi, in vista di piccole isole scultorie belle come le più belle delle Cicladi, vivendo all’aria aperta, nell’oro solare come nel nativo elemento, tra un popolo seminudo, il giovinetto aveva appreso a studiare la grazia e la forza del corpo umano come lungo i portici e sotto i platani dei ginnasii. La pelle fosca dei fanciulli balzanti giù per gli scogli, colorata e indurita dal sole e dalla salsedine, aveva dato allo statuario adolescente «il senso del bronzo». L’energia plastica affluiva alle estremità delle sue dita incessantemente per riprodurre. Ed egli, per una specie di affinità elementare, nel foggiar la creta, aspirava al fuoco terribile come al suo cooperatore necessario.
Ponete mente a questo. Io ho significato altrove, con una imagine, la presenza della Natura nelle opere del grande periodo ellenico. Ho detto: «Apritemi il torso di un dio greco; e ne vedremo erompere la nube o la luce, i baleni o i vènti del cielo.» Le statue allora non erano se non miti concretati in materie tangibili; non erano quindi se non figurazioni delle forze elementari, animate d’acque e di raggi, di suoni e di soffi. Fidia che solleva alle fronti del Partenone i suoi gruppi, il Giorno, la Notte, le Stagioni, i Fiumi, le Divinità marine, Selene, Demetra, ha per noi l’aspetto di un Atlante che solleva la Terra intera vivente con le sue arterie cristalline e con le sue vertebre lapidee. Nei templi di Delo eravi l’uso di profumare i marmi santi con un’essenza di rose; ma non erano essi già impregnati d’essenza divina? Le creature dell’infinito spazio, che Prometeo catenato invoca nella tragedia di Eschilo, avevano in quei marmi la lor sede ideale. Il popolo contemplando l’Ilisso o il Cefiso fidiaco udiva, in fondo al marmoreo silenzio, scorrere la santità del fiume padre.
Nel giovinetto campàno riviveva quel sentimento primitivo delle forze naturali. Gli aspetti delle cose apparivano divini alla sua inconsapevolezza. Foggiando la nudità umana nell’argilla dei Campi Flegrei, egli aveva inconsapevolmente l’anima religiosa dello statuario ateniese intento a cogliere le attitudini degli efebi e delle canefore nella processione delle Panatenaiche. La forma espressiva escita dalle sue mani aveva tanta intensità e larghezza di vita perché lo sforzo dell’arte era come avviluppato da un sogno confuso ma palpitante che comprendeva in sé le visioni quasi direi favolose delle potenze ond’è governato l’Universo.
Ora figuratevi questo artefice virgineo che, dallo spettacolo del mare delle valli dei monti dei bei corpi atteggiati, passa d’improvviso allo spettacolo del Genio!
Egli aveva nome Vincenzio Gemito. Era povero, nato del popolo; e all’implacabile fame dei suoi occhi veggenti, aperti su le forme, si aggiungeva talora la fame bruta che torce le viscere. Ma egli, come un Ellèno, poteva nutrirsi con tre olive e con un sorso d’acqua. Un giorno, per intercessione d’un altro artefice, il Maestro lo beneficò senza conoscerlo: pagando un tributo, lo riscattò dalla servitù militare, lo serbò alla libertà dell’arte.
In qual modo era per manifestarsi la riconoscenza del giovinetto oscuro verso il gloriosissimo Vecchio? Con l’atto più nobile e più pronto di cui egli fosse capace: con un atto creativo.
Quel corpo tuttavia robusto, tenuto diritto da una fiera armatura di ossa, irrigato dal buon sangue contadino, coronato da una testa imperiosa, gli apparve come l’involucro umano d’una forza senza limiti, sacra e inconoscibile. Simile al gioco dei vènti era sul mondo il gioco delle sue melodie. Sprigionate da quel cuore profondo esse percorrevano gli spazii, superavano i pelaghi e le montagne, squassavano l’anima dei popoli come i nembi squassano le miriadi frondose, trasfiguravano la vita innumerevole in un attimo come il soffio subitaneo trasmuta il colore degli oliveti, delle ombre, delle praterie, delle acque. Tanta virtù si generava da quella creatura incanutita, solcata dagli anni, raccolta in una tristezza austera, soggetta alla legge del deperimento, piantata su la terra come ogni altra creatura umana! E nondimeno egli non era un uomo ma l’incarnazione di un Elemento.
Imaginatevi quegli avidi occhi giovenili spalancati sul Genio, avidi del miracolo, in attesa della grande epifanìa. Non v’è dunque similitudine tra lo spirito di quell’aspettante e lo spirito dello statuario antico in atto di dar effigie a un mito solare o a un mito oceanico? Egli aveva là pronta la materia fittile, la massa informe e neutra che i suoi pollici impazienti non osavan premere, aspettando l’attimo in cui da quella fronte, da quelle sopracciglia, da quella bocca fatte sovrumane doveva irradiarsi una rivelazione fulminea.
E l’attimo giunse. Il giovinetto aveva seguìto il Maestro come un mendicante, nel tempo medesimo audace e timido, talora a piedi scalzi, facendosi leggero e tacito come una larva. Ne aveva spiato i passi le attitudini i gesti, i guizzi dei muscoli, i battiti delle palpebre, i baleni dello sguardo. Ma un giorno alfine poté penetrare all’improvviso nella stanza dove il Maestro meditava solo; e lo vide seduto, con la faccia china nell’ombra, con la fronte formidabile nella luce, con la barba sul petto respirante: aspro respiro d’un mondo in travaglio, silenziosa massa di vita generante, formazione lenta e inarrestabile d’una verità nuova organata come un essere.
Lo vedete voi là, nell’ombra, il fecondo padre? Non trattenne il grido colui che lo aveva veduto; e, d’improvviso, egli sentì in sé la forza stessa del miracolo che gli si era rivelato; sentì in sé la stessa urgenza che pareva sollevare quella fronte come la crosta terrestre che s’inarca in altura. E la necessità di perpetuare in una forma sostanziale l’apparizione fuggitiva si presentò a lui come un comando cui bisognasse obbedire senza indugio. Egli scomparve, fuggì, attraversò le vie come in un rapimento, salì la collina in corsa, giunse ansante dinanzi al cumulo dell’argilla, con rapidi colpi comunicò la sua febbre alla materia inerte, la maneggiò, la sconvolse, la infiammò, ne fece una cosa viva che parve formarsi a simiglianza di un’anima entro anelante, come se allo sforzo delle sue mani corrispondesse un interno lavoro misterioso. Ed egli era all’aperto, aveva dinanzi a sé le acque, l’arco del Golfo, l’orizzonte marino, la declinazione del sole. E, nell’ora labile, tutte queste grandi cose operavano con lui su la poca argilla e v’imprimevano i lineamenti della lor grandezza. Ed egli palpitava e anelava, calando il sole, diminuendo il giorno, perché sentiva l’impossibilità d’interrompere l’opera e di ritrovare quell’impeto. E tutte le cose lo aiutarono; l’ansietà del suo cuore accelerò il ritmo del mondo. L’ombra cadde sul mare, sul vulcano, su la città strepitosa, su la gran fronte del simulacro carica di melodìa ignota, su quel monte di volontà e di pensiero, cui le ciocche dei capelli salde e ricurve sono come quelle insegne della potenza che gli Orfici diedero alla fronte del dio Pan.. Son io riuscito a rappresentarvi con la parola quell’ora sacra ed a significarvi per via d’imagini la terribilità degli spiriti geniali, la reverenza religiosa e lo sbigottimento ch’eglino suscitano in chi è degno di mirarli? (…) Quanto diversi i due destini! Vincenzio Gemito, questo postremo figlio dell’Ellade che nel suo nome stesso portava la vittoria e il dolore, al colmo della sua virilità feconda, fu colpito dal male, abbattuto, avvilito, fatto carne vegetante. Senza morire, egli è rientrato nel mistero: nel mistero della follia che è più cupo della tenebra sepolcrale. Spento, infranto fu colui che seppe darci un’effigie così viva e solenne del Vecchio inesausto, colta nel tempo in cui questi era all’inizio del silenzio trilustre donde doveva poi irrompere con un volo inatteso (…) Il coraggio indomabile, la volontà di operare, il desiderio di tentare l’ignoto non ebber mai una espressione più virile”.
Lucilla Parlato

Giornalista professionista dal 1997, ha vissuto e lavorato 20 anni a Roma. Nel 2014 è tornata a Napoli dove ha fondato con Drusiana Vetrano e altri “Identità insorgenti” quotidiano che ha diretto per 7 anni. Nel 2021 è tra i fondatori del portale SulSud. Rivendica orgogliosamente le sue radici suddiste: è figlia di Antonio Parlato che al Sud ha dedicato la sua intera esistenza, di cui spera di aver raccolto degnamente l’eredità culturale.
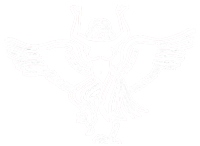

Devi essere loggato per commentare Login