Cinema
“E’ stata la mano di Dio”: il dolore di Sorrentino diventa grande bellezza

Il binocolo era il nostro “localizzatore” una volta. Vivevamo col walkman in cuollo, noi ragazzi negli anni ’80-’90, quasi un prolungamento di noi stessi… anche gli oggetti raccontano.
Paolo/Fabietto, il walkman ce l’ha anche in ospedale, il giorno in cui diventa improvvisamente grande restando per sempre bambino, nella scena in cui apprende della morte di entrambi i genitori, quando urla quel disperato “Me li dovete far vedere”.
E questa diventerà la sua storia da raccontare. 35 anni dopo l’evento che ha segnato la sua esistenza.
Quel non l’avere visto materialmente i corpi morti di suo padre e sua madre è l’emblema della grande ferita mai rimarginata della sua vita. come ha spiegato lui stesso in tante interviste.
La ragione dell’andare via, del disunirsi per fuggire al dolore.
Perché è difficile, quando sei ragazzo e hai delle ferite già aperte di tuo, riuscire a guardare senza soffrire la parte buia di questa città, capace di abbagliarti e di rubarti la luce.
Così quel piano sequenza iniziale di “E’ stata la mano di Dio” vale per me tutto il film: un percorso dalla luce al buio, dal sole alle tenebre, dal dolore alla speranza. Anche in un altrove, lontano, dove rifugiarsi.
Perché Napule è.
Napule è questo.
E’ la sensualità della zia-sirena, Patrizia. E’ l’arcigneria della signora Gentile. E’ la guasconeria del papà di Fabietto. E’ la goliardia, nonostante tutto, della mamma.
Napoli ti può far sentire smarrito e orfano come Fabio e ti può accogliere con la sua mostruosa e morbosa sete di vita, come quella terrificante e liberatoria della baronessa.
E’ la comprensione e l’empatia per l’altro, anche per chi fa una vita opposta, come quella del contrabbandiere che diventa amico di Fabietto, semplicemente, tra una curva del San Paolo o offrendogli una serata di mancata follia a Capri, consolandosi con un bagno di notte nella grotta azzurra.
Perché la poesia che ci circonda, è qualcosa di incredibilmente semplice se siamo in grado di coglierla.
E’ la storia, il nostalgismo permanente e inascoltato dello zio.
E’ San Gennaro e ‘o Munaciello: la mescolanza naturale tra sacro e profano.
E’ il presepe eterno e l’eterno teatro.
E’ la non perseveranza del fratello.
E’ una corsa a tre in vespa nelle curve della grande bellezza di Posillipo.
E’ il sogno di Fabio di fare il regista di film, da grande.
E’ il citarsi e autocitarsi: perché ci si può sentire parte integrante e, insieme, assoluti estranei in questa città.
E mi domando che film abbiano visto la patetica pletora di critici improvvisati che hanno commentato che dentro “E’ stata la mano di Dio” “c’è poca Napoli”.

Questa premessa per spiegarvi perché ho amato profondamente il film di Paolo Sorrentino.
Perché a parte l’atto di onestà, anche artistica, è difficile raccontare, senza risultare patetico, quella ferita d’abbandono impossibile da rimarginare, usando insieme ironia e sensualità, entrambi strazianti.
Sarà che a personaggi di uno spessore di profondità come questi, ormai siamo disabituati.
Sarà che tra commissari, finti-Eduardi e pipponi intelluettuali, siamo incapaci di assorbire certe narrazioni di noi.
Mentre, per me, questo film è Napoli: quella Napoli tra gli ottanta e i novanta – post colera, post terremoto, post guerra di camorra – alla quale Maradona era appunto apparso. Mentre noi vivevamo le nostre vite, a volte drammatiche o dilanianti. E intorno a noi la festa del riscatto illusorio eppure alleviante. Attorno a noi, anche, il cinema nascente di Capuano, Martone, Corsicato, che ci faceva sognare, pensare, conoscere la città.
Lo hanno capito ragazzi, ovviamente molto più giovani di me che lo hanno amato allo stesso modo, senza aver vissuto quei giorni, quel clima dove davvero erano i palazzi, anche nei quartieri borghesi come il Vomero, a parlare, tremando a ogni gol del DioS.
A sussultare d’altro, dopo i tremolii della terra sotto di noi, che c’avevano abituati alla precarietà fin da bambini.
Lo hanno capito anche perché come dice Paolo, questa è una città che cambia poco.
Per noi coetanei di Paolo, in più, è inevitabile quel tuffo malinconico nel passato.
Come nell’apparizione di piazza del Plebiscito-parcheggio, che guarda caso avevo citato come simbolo di quegli anni, senza sapere che nel film è stata ricostruita esattamente così, come allora.
Noi precari dell’anima come possiamo non sussultare a quella scena?
Come possiamo non rievocare la nostra infanzia leggera, da tre mesi di vacanza al mare, quando zia Patrizia, mollemente adagiata, nuda, nelle acque davanti a Isca, l’isoletta di Eduardo mostra la sua sirenitudine e la sua abbagliante bellezza e follia?
“Non è facile trovare le parole per spiegare gli appuntamenti coi ricordi. Sono delle sensazioni difficili da verbalizzare. E’ molto utile vivere qua se si vuole raccontare delle storie” racconta Sorrentino nell’intervista-contenuto speciale su Netflix.
Non è facile, ma con il suo mezzo, il cinema, Sorrentino ci riesce benissimo, soprattutto nella scena clou con il suo “mito” e primo mentore, Antonio Capuano, nella bellezza abbagliante di alcune grotte di Posillipo che affacciano sul mare, che per il regista sono un po’ l’emblema di Napoli, un posto che dalla chiusura, dal buio, porta all’apertura.
“Tornare a Napoli è un contrasto evidente: scontrarmi col massimo della gioia e col massimo del dolore” spiega Sorrentino, nell’intervista su Netflix.
Che poi vuol dire che chi ha letto questo film come un invito al fujtevenne, ha capito ben poco.
In poesia è spiegato nel dialogo con Capuano.
Fabietto: “Voglio una vita immaginaria uguale a quella che avevo prima. La realtà non mi piace più”.
Capuano: “Non basta Schisa, non basta. Vogliono fa tutte quante stu cazz’e cinema. Ma pe’ fa ‘o ccinema ci vonn’e palle. E tu ‘e palle le tieni, guagliò?”
Fabietto: “Ho fortissimi dubbi”
Capuano: “E allora ti serve un dolore. ‘O tieni un dolore?”
Fabietto: “Mi hanno lasciato solo, Capuano. E questo si chiama dolore”.
Capuano: “Non basta, Schisa!! C’hanno lasciati solo a tutte quante. Tu sei solo? Nun me passa manco p’o cazzo! Perché tu non sei originale.
Siente a me, dimenticati il dolore. E piensa solo a t’divertì. Accussì hai fatto il cinema. Si, però, e’ tené coccos’’a ricere. ‘A tien’’na cosa a ricere, o no?
Perché vedi la fantasia, la creatività, so falsi miti che nun servono a nu cazzo”.
Fabietto: “Pensavo di andare a Roma a fare cinema così capisco se ci sono tagliato”.
Capuano: “A Roma? La fuga? So palliativ d’o cazz. Alla fine torni sempre a te Schisa. E torni qui, torni al fallimento. Perché è tutto un fallimento, una cacata. Hai capito o no? Nessuno inganna il proprio fallimento e nessuno se ne va veramente da questa città.
Roma? Ma che cazzo ci vai a fa’ a stu Roma? Solo ‘e strunz vanno a Roma. Ma hai visto quante cose ‘a raccuntà c’stanno int’a chesta città? A tieni na storia a raccuntà?…”
Questo film è, semplicemente, la risposta.
(aggiornamento dell’8 febbraio 2022: il film è candidato all’Oscar come miglior film straniero”)

Giornalista professionista dal 1997, ha vissuto e lavorato 20 anni a Roma. Nel 2014 è tornata a Napoli dove ha fondato con Drusiana Vetrano e altri “Identità insorgenti” quotidiano che ha diretto per 7 anni. Nel 2021 è tra i fondatori del portale SulSud. Rivendica orgogliosamente le sue radici suddiste: è figlia di Antonio Parlato che al Sud ha dedicato la sua intera esistenza, di cui spera di aver raccolto degnamente l’eredità culturale.
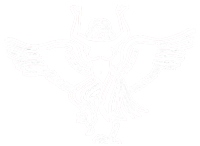

Devi essere loggato per commentare Login