Diritti e sociale
L’OMAGGIO / Dove inizia la notte (morna per Willy Monteiro Duarte)

A Napoli si radunano a Montesanto, davanti a un bar di fronte alla stazione della ferrovia cumana. Occupano chiassosamente una ventina di metri di marciapiedi fra tavolini di pvc, sedie e una caciara che passarci in mezzo ogni pomeriggio è una doccia calda di vitalità. Le donne di Capo Verde hanno una parlantina e un tono di voce che, quando chiacchierano in gruppo, stordirebbero chiunque. Parlano, si prendono in giro, litigano, ridono, si chiamano l’una con l’altra a volume assurdo. Fanno “nu burdello ‘e pazze”, diciamo da queste parti. E sono parte di questa città, di questo quartiere, ormai da anni. E sembrano secoli, questi anni, perché se è vero che c’è un po’ di Napoli in tutti i popoli del mondo, i capoverdiani sono una delle popolazioni più napoletane del pianeta. E qua ci stanno come il rum sopra il babà, per quanto naturalmente la loro chiassosa allegria si mescola a un velo di malinconia che vela i loro occhi appena si fermano un attimo in silenzio a guardarsi dentro e lontano.
A Capo Verde hanno una delle musiche più belle che si siano mai sentite al mondo: la morna. Un misto di fado, di saudade, di blues e di cante jondo che è un concentrato di ogni possibile tipologia di malinconia traducibile in note sopra un pentagramma. E chi altri avrebbe mai potuto partorire una musica così evocativa e struggente, se non gli abitanti di una terra che, dal 1464 fino al 1850, è stata il maggior porto di partenza degli schiavi africani verso le americhe? Quattro secoli di tratta degli esseri umani, quattrocento anni di uomini in catene, anelli di metallo al collo, catenacci, fruste e palle al piede. E dopo, solo siccità, terra arida, emigrazione e una terraferma troppo lontana perché la comunità internazionale si accorgesse che questo arcipelago sperduto in mezzo all’oceano di fronte al Senegal era una landa imbevuta di poesia, di musica e di una gentilezza nata sopra quattro secoli di infamia e sangue versato da esseri umani trattati come bestie da altri esseri umani per un tempo così lungo che ancora oggi interi pezzi di pianeta pagano con la vita il prezzo del business più redditizio che il mondo abbia mai visto: il razzismo.
Capo Verde ha dovuto aspettare Amilcar Lopes de Costa Cabral per ottenere l’indipendenza nel 1975, qualche mese dopo il suo assassinio e due anni dopo la Guinea-Bissau sulla terraferma. E basterebbe studiarle, queste quattro semplicissime righe di storia, per comprendere che noi europei e gli americani abbiamo un debito con queste persone. Così come abbiamo un debito con tutti i paesi africani (che sono profondamente diversi l’uno dall’altro per cultura, lingue e religioni, ma qui da noi se ne sono accorti in pochi…), con gli aborigeni australiani, con i nativi americani del nord e del sud. Basterebbe insegnarla e studiarla, un po’ di storia, per capire il mondo e gli esseri umani. E uscire dal feroce guscio di odio in cui noi tutti occidentali ci siamo rinchiusi sparando contro qualunque creatura che non assomigli a noi. E al nostro brutale egoismo.
Willy Monteiro Duarte era un esile ragazzo italiano di 21 anni, nato in provincia di Roma da genitori capoverdiani già da anni radicati qui. Nato in questa terra come me, come te, come noi, come voi. Un ragazzo che non aveva meno diritto di me di amarla, questa terra e di viverci da uomo libero, con diritti e doveri, come qualunque cittadino. Come me, che ho antenati greci, sanniti, romani, bizantini, saraceni, normanni, svevi, francesi, ungheresi, austriaci, spagnoli. Un groviglio di sangui che fanno di me un cittadino del mondo con il nome di una nazione occidentale stampata sopra un passaporto. Willy Monteiro Duarte era andato a scuola ed era stato uno studente migliore di quanto non lo sia mai stato il sottoscritto. E sicuramente sarebbe diventato un cittadino molto più civile delle creature sub-umane che lo hanno massacrato. Willy Monteiro Duarte è l’ultimo martire in ordine cronologico del lungo cammino di libertà dei popoli oppressi. Figlio di una generazione partita lontano dalla propria terra martoriata. Carichi di forza di volontà, perseveranza e speranza di riscatto.
Sui quattro assassini che l’hanno ucciso ieri si è detto già tutto, sul web: esaltati, spietati, pericolosi, imbevuti di culto della forza bruta, sessisti, violenti e disumani. La loro esistenza si divide fra palestre, discoteche, risse, spaccio, macchine sportive, selfie Gomorra style, camicie a fiori, tatuaggi full body, e sguardi agghiaccianti da gangsta senza alcun barlume di umanità negli occhi. Praticamente un cliché. Lo stereotipo oggi più in voga: il maschione bullo depilato e tatuato tutto muscoli, arroganza e modi tamarri da boss di provincia. Quanti ne incrociamo per strada, ogni giorno? Tanti, troppi.
Non raccontiamoci frottole: la devianza giovanile è sempre esistita. Negli anni ’70 gli scontri (spesso mortali) fra militanti comunisti e neofascisti erano all’ordine del giorno. E prima di allora, Pasolini aveva tracciato con spietata esattezza la controstoria del boom economico (che gettava, in quegli anni, le basi dell’ attuale deriva materialista), raffigurando le esistenze disperate e violente dei “ragazzi di vita” delle borgate romane, che sono gli stessi di Scampia, delle banlieue parigine, dei sobborghi londinesi, delle favelas di Rio, di Los Angeles e di certi inferni del Guatemala. E chiunque di noi ha avuto le sue sacrosante scazzottate, a scuola, per difendere il “chiattone” indifeso dalle aggressioni del bulletto fascista di turno. Un occhio nero e via. La vita non la rischiavi, perché c’era un limite, un pudore di fronte alla morte che pochissimi osavano superare. La novità di oggi è che anche l’ultimo tabù è caduto: uccidere senza motivo è diventata la normalità. Un evento possibile nella nostra quotidianità. E non si ammazza per fame, lotta politica, per rapina. Si ammazza per sport, per puro esercizio di narcisismo. “Sono più forte e ti elimino perché tu sei più debole e vai schiacciato”. Ovvero: la pietra tombale sul concetto stesso di evoluzione. Un grande vuoto, riempito di violenza.
Com’è potuto accadere che dei ragazzi dai 22 ai 25 anni non poveri, non orfani, non disoccupati e non disagiati abbiano potuto massacrare, fino a togliergli la vita, un ragazzetto sottile come una sfoglia che era intervenuto per mettere pace in una lite, e come sia stato possibile che uno dei quattro (cinque, secondo le ultime notizie) abbia addirittura chiamato rinforzi per sopprimere una vita di cui non conoscevano nome, storia e sogni? Non per rapina, ma solo perché “negro”, inferiore e più debole. Sono queste le domande a cui oggi dovremmo iniziare a tentare di rispondere. Nessuno nasce malvagio. Perché lo si diventa?
Non basta inondare il web e i social di foto dei criminali e scriverci sotto “Carcere a vita, anzi, impiccagione per le bestie fasciste” per chiamarci fuori ed assicurarci un posto a vita dalla parte dei “buoni”. Anzi… Ciò che abbiamo letto oggi sui social è, se possibile, ancora più agghiacciante di quanto accaduto: “Mi auguro che in carcere vi stuprino, fighetti depilati”, “Meritate di essere impalati”, “Per voi niente processo, fucilazione immediata”… Sì, sono dei vermi. E dunque? Tutto qui? Fine del discorso? No. Non possiamo cavarcela così. Non può e non deve bastarci, questa narrazione.
Ci siamo imbarbariti, tutti. E abbiamo smesso di porci domande. Nessuno, finora, si è chiesto quali siano le dinamiche psicologiche, sociali, economiche e (sotto)culturali che possano portare quattro esseri umani a vivere di violenza, quali sono i loro modelli, dov’era la scuola mentre questi malviventi maturavano le loro scelte criminali, dov’erano le famiglie, dov’era lo Stato.
Neanche la componente civile sembra riuscire a superare il mero, barbarico insulto e l’augurio di morte violenta. Uscendone macchiata. Non come gli assassini, ma cadendo vittime delle stesse trappole mentali. Il “Devi morire” regna sovrano, nell’epoca della pura apparenza, del mito della bella macchina, del vivere da vip, calpestando tutto e tutti, della ricchezza come unico valore, del culto della sopraffazione del più forte sul più debole, sul diverso, sulla donna, sul gay, sullo straniero. Era da trent’anni, che si preparava questa tragedia. Trent’anni di televisione spazzatura, di trionfo del trash, di isoledeifamosi, di fabrizicorona, di truffatori prescritti che diventano influencer e di politica malata, deviata, che ha completamente abdicato dalla più elementare idea di etica e visione di un futuro collettivo.
Qualcuno di voi si era illuso che i pestaggi da dittatura militare alla caserma Bolzaneto di Genova 2001 non avessero alcun effetto a lungo termine, nell’immaginario popolare e nei comportamenti sociali? Qualcuno si aspettava che non sortisse alcuna conseguenza il ritorno in Italia di un personaggio come Roberto Fiore (terrorista pluricondannato) dopo 14 anni di latitanza, a cui viene permesso di fondare un partito neofascista e di fare tribuna politica in televisione? Qualcuno pensava che la violenza verbale quotidiana di Salvini e dei suoi seguaci razzisti non aprisse squarci di inaudita, incivile ferocia nei cervelli e nei comportamenti quotidiani dei suoi fans…? Qualcuno immaginava che non lasciasse alcuna traccia la lenta, capillare opera di abbattimento, uno dopo l’altro, di tutti i pilastri di una democrazia come scuola, sanità, giustizia, lavoro e politiche sociali perpetrata nel trentennio berlusconiano-dalemiano, in quel lungo autunno che ora spalanca le porte a un inverno che rischia di essere buio come e più di cento anni fa..?
L’omicidio colposo di Willy, figlio di una terra lontana, triste e sperduta nell’oceano Atlantico, l’Italia intera lo stava pianificando da trent’anni. E l’altro ieri lo ha messo in atto per mano di quattro perfetti prodotti nostrani del terzo millennio. Figli di un popolo svuotato di ogni umanità, privato di visione del futuro. Un popolo incattivito, rancoroso, anaffettivo, egoista e violento. E di uno Stato demolito nelle sue stesse fondamenta. Le quattro belve di Colleferro sono le nostre macerie, i cocci dell’Italia in frantumi.
Abbiamo una sola speranza: guardare in faccia questo male e cambiare. Piantare semini di civiltà che vedremo germogliare solo fra un bel po’ di anni. Opporre gentilezza e cultura ogni volta che la clava della brutalità prova a riportarci all’età della pietra. E riuscire a liberarci dei cattivi modelli oggi dominanti. O scegliere di cadere, nel paese di Beccaria, nella trappola della sedia elettrica, ovvero: ucciderne quattro per ritrovarsene altri cento, simili al camerata neonazista che l’anno scorso se ne andava a passeggio per Macerata sparacchiando fucilate contro “i negri che minacciano la nostra identità nazionale”.
Non vogliamo vendetta, vogliamo giustizia. Vogliamo scuola. Vogliamo servizi sociali. Vogliamo cultura. Vogliamo civiltà.
Siamo una terra malata da bonificare. E non sarà altro odio, a salvarci.
Altrimenti, ci aspetta una lunga notte.
Maurizio Amodio

Maurizio Amodio nasce a Napoli nel 1970 da un’insegnante elementare e da un professore di filosofia. Vive da 0 a 19 anni a Piazza Dante dentro il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele ll, dove il papà, in quanto Rettore, ha l’alloggio. Impara già in tenera età a rispettare la natura perchè dalla finestra gli entra un ramo di magnolia in camera e a 14 anni si cimenta nel commercio gestendo un fitto contrabbando di riviste porno con i convittori interni della struttura. Colleziona gatti per tutto l’arco della sua vita. Studia pianoforte, ma le dita corte non gli permettono di diventare il nuovo Maurizio Pollini. Quando il Napoli vince il primo scudetto, si arrampica sulla torre dell’orologio del Convitto e sostituisce la bandiera italiana con una del Napoli Calcio raffigurante la faccia di Maradona. Per tutti i suoi anni universitari si paga i lenti studi facendo lezioni private e lavorando nei pub, dove fa anche acchiappanza con le femmine, oltre che frequente abuso di alcool. Nel frattempo, continua a spendersi tutti i soldi in dischi, libri e profilattici. Nel ’94 rifiuta il servizio militare, va sotto processo come renitente alla leva, si difende da solo, vince e alla fine va a guidare l’ambulanza come obiettore di coscienza in un posto sperduto degli appennini, dove fa altre acchiappanze rurali. Collabora col WWF come educatore ambientale, partecipa ad Agenda21 per tre anni e alla fine se ne va sbattendo la porta. Nel frattempo è anche traduttore, fotografo e insegna italiano alla comunità senegalese. La svolta nel ’97, quando entra a Napoli Sotterranea. È lì che impara a parlare in pubblico senza timidezze e diventa speleologo e guida turistica, attività che ancora oggi svolge in proprio in tutta la Campania. Nel 2020 entra fisso nella redazione di Identità Insorgenti, primo passo verso la futura assegnazione del Premio Pulitzer. p.s.: sigarette fumate: Rothmans demi. Taglia di abbigliamento: M. Numero di scarpe: 43.
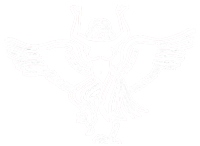

Devi essere loggato per commentare Login