Identità
VISTO DA DENTRO / Così abbiamo vissuto San Gennaro senza fedeli

Francesco Imperiali, figlio di Riccardo – responsabile legale e componente della eccellentissima Deputazione della Real Cappella del Tesoro. Ogni tanto collabora con il nostro giornale. Questa volta gli abbiamo chiesto di raccontarci “da dentro” la giornata di ieri, quando per la prima volta nella storia non si è svolta la consueta processione e i fedeli hanno potuto assistere solo virtualmente al prodigio. La gallery fotografica è invece di Salvatore Laporta dell’agenzia Kontrolab.
A casa mia San Gennaro non è un giorno, è un periodo. Inizia giorni, settimane, prima del miracolo.
Una lenta preparazione con uno schema preciso: si cacciano i portaabiti, riposti in un armadio in alto, di quelli che contengono materiale che si usa poco, per capirci. Qualche anta più in là, giace la roba di Natale.
Forse i piani più alti degli armadi sono proprio per quando il credo si impregna di fiaba, sacro e profano si mischiano inevitabilmente per condividere stipi stretti: come il pacchiano costume di Papà Natale sfiora il più religioso presepe, fiero della sua rappresentazione della natività, così il mondano frac si stringe alla fascia rossa, al papillon e al gilet che è, innaturalmente, nero, per rispetto alla Chiesa.
In fin dei conti, San Gennaro, a casa mia, è sempre stato come il Natale. E come il Natale ha un posto certo nel calendario, porta con sé una sua specifica ritualità, è sacro ed è anche festa gioiosa.
Compare il frac, viene appeso all’aria, quasi a volerlo riabituare alla luce, stirato. È una bandiera che per almeno una settimana ricorda ai passanti del corridoio che ci siamo: il giorno è vicino. Un abito da sposa per un matrimonio che si ripete tre volte l’anno.
Una stampella appresso si stende la fascia, rossa, rosso-sangue si direbbe per descriverla se non fosse un po’ fuori luogo il confronto in questo contesto, o forse è proprio adatto.
Sotto la fascia penzola un monile: una croce che al centro porta uno stemma. “Non è un gioco”. No, non lo è, l’ho capito ormai: racchiude la storia più viscerale di Napoli, quella dei Sedili, le antiche circoscrizioni che hanno governato la città sin dalla sua fondazione e che solo nella storia moderna si sono perse, ma timidamente resistono ancora nella loro ultima rappresentazione: la Deputazione.
Sul nostro vi è il cavallo, Sedil Capuano.
C’è poi la camicia e sotto, sul servo muto, è poggiata la scatola aperta con la bottoniera in bella vista: “è quella di Zio Lucio”, me lo ripete ogni volta mentre la mette. Si commuove sempre un po’ al suo ricordo.
E poi c’è lui, protagonista indiscusso: il fazzoletto. Bianco. In un ricamo nell’angolo, vezzo di vanità, ci sono delle cifre coronate, per ricordarsi che si è lì a rappresentare la famiglia intera, non è l’uomo singolo, ci sono gli avi che vigilano. Sempre. Non ci si può permettere di sbagliare: noblesse oblige…
Si prova il frac. È sempre lo stesso, non ce ne sarebbe necessità, ma “bisogna stare in ordine: è rispetto per chi guarda”. Che galante.
“Come va?” scherza. È ingobbito un po’, pesa la millenaria storia che porta sulle spalle da solo, ma l’occhio è vispo ed entusiasta, allora non glielo dico, sono solo le prove.
Arriva il giorno.
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- chiesa del duomo vuota il giorno del miracolo di san gennaro fedeli credenti coronavirus covid 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- chiesa del duomo vuota il giorno del miracolo di san gennaro fedeli credenti coronavirus covid 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19- Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- Napoli miracolo San Gennaro al tempo del virus coronavirus COVID 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- chiesa del duomo vuota il giorno del miracolo di san gennaro fedeli credenti coronavirus covid 19- Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
- chiesa del duomo vuota il giorno del miracolo di san gennaro fedeli credenti coronavirus covid 19 – Foto Salvatore Laporta – Kontrolab – Tutti i diritti riservati
L’ultima a venir cacciata fuori è la chiave, rigorosamente custodita sino a quel momento, fisico riassunto della consegna ricevuta, apre la cassaforte contenente le ampolle con il sangue del Santo.
Si prepara.
Schiena di nuovo inarcata in avanti, mia madre che dice “non fare Andreotti” e lui si raddrizza, allarga le spalle e un po’ si offende. Non per Andreotti in sé, ma perché è politica e quindi non sta bene. È tra gli argomenti tabù, come i soldi, la salute: non se ne parla. Come la fede. La sfera intima è propria del solo io. Se si potesse riassumere tutta l’intangibile enciclopedia dell’educazione in una frase sarebbe, forse, questa.
La fede, ma non San Gennaro. San Gennaro è un’altra cosa, di lui si può parlare. Non della fede in lui che è cosa ben diversa, ma di lui come istituzione, come tradizione, come momento di comunità.
È così da sempre, ogni singolo gesto potrei precederlo in una sceneggiatura che conosco a memoria, tenero déjà-vu.
Quanti anni avevo la prima volta? Sette. Non lo so. Di meno? Forse. Certo, ero piccolo. Cerco di fare ordine nella memoria.
Mi ricordo di mio padre dietro al busto in processione insieme agli altri Deputati impettiti, io che scorrazzo indisciplinato avanti e indietro e Bassolino, Sindaco, che prendendomi sottobraccio dice “Francé, vieni a cà”. Papà si volta indispettito, ma non è politica e allora si può, per cui con un cenno sorride e ringrazia il signore un po’ rauco che mi si prestava a balia.
Ricordo confusione, festa, gente, urla, rumori.
E poi c’è oggi.
Dove c’era la fisicità delle migliaia di persone oggi c’è l’online, dove c’era il rumore, oggi c’è il silenzio.
Ma il silenzio fa molta più paura. A pensarci forse l’evoluzione ha fondato tutto sul rumore: dall’uomo delle caverne ad oggi il perfezionamento della tecnica, spesso tecnologia, è servito a coprire i pensieri, a evitare di doversi sentire.
Ci si è distratti in un frenetico -rumoroso – quotidiano, pur di non pensare. L’uomo, animale sociale che deve tutto alla propria capacità di riflettere e di confrontarsi, ha deciso di ritirarsi dal gioco: non più pensiero, non più comunità, meglio isolarsi e andare avanti per inerzia, senza alcun valore aggiunto. Senza pathos, vietato soffrire. Ma la sofferenza è come la critica: può essere negativa o positiva ed è comunque sempre volta al miglioramento, senza ci si appiattisce in un risultato scarno.
Ci siamo riusciti: siamo figli di questo risultato scarno. Avevamo giornate piene di niente, rigorosamente soli in mezzo alla gente, travestiti da sociali nell’ostentazione digitale, mascherati da felici, che poi a dirla tutta, sarebbe sempre una sensazione figlia del sentimento…
E adesso?
Non c’è la processione. “Ma è il miracolo di maggio!” contestano i più devoti, o forse solo i più legati alla forma. Effettivamente, però, la processione c’è sempre stata. Dal Duomo a Santa Chiara per ricordare la traslazione delle spoglie del Santo. Ha vinto pesti ed epidemie passate, ma ai giorni del Covid deve mutilare sé stessa: necessaria precauzione in tempi di contagio.
Celebrazione a porte chiuse, in Duomo.
Così tra le certezze che credevamo di avere e che l’attuale pandemia porta con sé si aggiunge anche quella di vedere migliaia di persone riversate per le strade e in Chiesa nei giorni del Patrono.
Sorriso amaro a pensare che il Deputato quando annunzia il miracolo sventola il fazzoletto per mostrare anche ai più distanti l’avvenuto prodigio, ma oggi il più distante in un Duomo vuoto è al massimo due metri lontano, come da ordinanza, lì dove, in versione inusualmente sottotono, siede il Sindaco De Magistris.
Come si riempie tutto quel vuoto?
Può tutto quel rumore tradursi in tutto quel silenzio? Che cosa hanno più in comune le celebrazioni di ieri e di oggi? Se si elide il folklore, compresi i cartelli con pizza o caffè o babà San Gennaro in offerta che si incontrano nei vicoli; se si elimina il sottofondo di preghiera che è un po’ litania un po’ insulto, ma non troppo ché altrimenti porta male, scaramanzia. Cosa resta? Tutta quella rumorosa confusione non era forse comunità? Quella vera. Allora è vero che oggi si è terribilmente soli.
Si scambiano uno sguardo, uno scambio consentito quando anche il segno della pace è vietato, il Cardinale e mio padre, quante parole dette in due occhi che si incrociano mentre la bocca è schermata dietro una mascherina, accessorio nuovo, forzatamente inserito in una divisa d’ordinanza che non cambia da secoli.
Sono lontani i giorni dei loro litigi e dei successivi chiarimenti, sono vicini quelli tormentati in cui decidere cosa fare in quest’anno di reclusione imposta. “Non possiamo non far niente”, l’ho sentito in tante telefonate. Avevano ragione: San Gennaro è la fede, differente e parallela, di chi ha necessità di trovare un conforto in uno sconosciuto amico, non si può vietare di frequentarlo. È immateriale ma c’è, come la processione di oggi.
Il Cardinale saluta, di solito questo momento si riempie di nomi di delegazioni che sono arrivate sino a Napoli per assistere alla cerimonia, stavolta è un “desidero porgere il mio cordiale saluto al signor Sindaco e all’illustre Avv. Imperiali”. Sono in tre, eppure lì c’è tutto il mondo.
E c’è anche San Gennaro che subito si manifesta e non insiste nell’attesa. Il fazzoletto sventola, più forte di sempre, per arrivare oltre chi vede. Si intravede nel labiale un accenno “per tutto il mondo”. Si consacra simbolo. È storia, nuova.
Si susseguono intanto i commenti sulla pagina della Cappella che trasmette la diretta: leggo immaginando il tono, ritrovo la litania, mi sento di nuovo protetto in uno spazio che conosco.
Escono sul sagrato, programma non ancora ufficializzato, per evitare eventuali assembramenti. Alzano gli occhi i tre, moschettieri di una battaglia comune, si affacciano dai balconi tutto intorno, è un po’ una processione, anche se fermi. Anche se non lo è.
Rientrando nella Basilica stringono le spalle, pare un brivido, deve far freddo in quella stanza: un Duomo così grande, con meno di dieci persone. A riscaldare allora sono le persone, calore umano non è soltanto un modo di dire.
Francesco Imperiali
Gallery fotografica Salvatore Laporta / Kontrolab – tutti i diritti riservati

SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
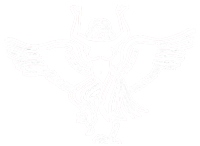


















Devi essere loggato per commentare Login