Identità
ADDIO DIEGO / Maurizio De Giovanni: “Non sei il più grande perché nella tua categoria non c’è nessuno e nessuno ci sarà mai”

Su fb il ricordo di Maurizio De Giovanni, lo scrittore grande tifoso del Napoli, ha sempre regalato meravigliosi racconti sul calcio e su Diego (da “La Lunga storia del gol più bello del mondo”
“Per me sei questo. Sarai sempre questo. Non sei il più grande, semplicemente perché nella tua categoria non c’è nessuno. E nessuno ci sarà mai.
La lunga storia del gol più bello del mondo
1. Pomeriggio a Fiorito
Alla fine della lunga salita, il sole che tramontava tagliava la strada in due. I ragazzi si buttarono nell’erba, all’ombra, il più piccolo col pallone consumato tra le braccia. Come al solito. Quando ebbero ripreso fiato si guardarono, e scoppiarono a ridere.
Il più alto, asciugandosi le lacrime, disse: ogni volta, Pelusa; succede sempre. Prima scommettono, perché ti vedono piccolo e pensano che è facile. Poi perdono, e dicono che abbiamo imbrogliato perché sei un nano, che non può essere che hai dieci anni, e cercano di riprendersi i soldi. Fortuna che glieli facciamo mollare prima, e che corriamo veloce.
Il piccolo si scostò i riccioli neri dalla fronte. Però hanno ragione, Goyo, disse. Non ho dieci anni. Ne devo ancora compiere nove. Risero di nuovo, poi El Goyo strappò un filo d’erba e se lo mise a masticare, mentre il piccolo indio cominciò a palleggiare da sdraiato col piede sinistro. Un vecchio passò in bicicletta, e per guardare lo spettacolo per poco non cadde; proseguì bestemmiando.
El Goyo disse: vedrai, Pelusa; quando sarai grande giocherai nel Boca, a Buenos Aires. Tutta Villa Fiorito ti verrà a vedere, anzi tutto il mondo, ti verrà a vedere. E tu magari farai come hai fatto oggi, te li scarterai tutti, compagni e avversari; anzi, pure il pubblico ti scarterai. E poi mi passerai la palla, perché ci sarò anch’io, e io te la ripasserò senza guardarti. E tu segnerai il gol più bello del mondo. E quando avrai segnato il gol più bello del mondo, ti daranno tanti di quei soldi, ma tanti di quei soldi che ti copriranno d’oro, e tu farai costruire una casa alta, alta fino al cielo per la tua famiglia. Ne sono sicuro, sai, Pelusa. Farai il gol più bello del mondo per il Boca.
Il piccolo indio non aveva smesso di palleggiare, mentre l’amico parlava; ma aveva ascoltato lo stesso guardandolo fisso in faccia, come se il piede sinistro fosse una parte indipendente del suo corpo, e avesse una propria volontà e occhi propri per osservare la vecchia palla bitorzoluta che andava su e giù.
Sì, Goyo, disse. Hai ragione, io giocherò sempre, perché la mia vita è il pallone e io non lo lascerò mai. E forse diventerò anche ricco, così la Tota non dovrà più piangere e don Diego, mio padre, lavorare fino a notte per dare da mangiare a me e ai miei fratelli. E lo farò, sì, il gol più bello del mondo, Goyo: te lo prometto.
El Goyo prese un altro filo d’erba, e si sdraiò affianco all’amico guardando il cielo incendiato dal tramonto. Sospirò. Sì, Pelusa, lo farai: e ascolta me, dovrai concordare prima il prezzo. Dovrai dire ai dirigenti del Boca: parlate col Goyo, il mio manager, e ditegli quanto mi darete se dovessi fare il gol più bello del mondo; se lui sarà d’accordo, gli dirai, allora mi farà un cenno, e al suo cenno io lo farò. Hai capito, Pelusa?
Il piccolo indio stette un attimo zitto, e smise di palleggiare. Poi disse, a bassa voce: no, Goyo. Perdonami, ma non sarà così che farò il gol più bello del mondo. E perché?, gli chiese El Goyo. Perché, rispose Pelusa, il gol più bello del mondo non può essere fatto per i soldi.
Che sciocchezze sono, queste?, disse El Goyo, sinceramente meravigliato. Tutto, si fa per i soldi! E’ un lavoro, sai, Pelu, un lavoro come tutti gli altri. Questi, per esempio – e si batté sulla tasca con un lieve tintinnio di monete – non sono forse soldi? E come li abbiamo guadagnati, se non giocando a pallone?
Pelusa taceva. Poi disse: sì, è vero. Li abbiamo guadagnati col pallone. Ma la Tota, sai, mi dice sempre una cosa: puoi fare grandi cose, Pelusa, ma le più grandi le devi fare per amore. Perché l’amore è la cosa più grande del mondo, e le cose più belle sono fatte per amore. E allora io, Goyo, devo fare il gol più bello del mondo per amore, non per soldi.
E siccome l’amore più grande è per la propria terra, Goyo, io farò il gol più bello del mondo con la camiseta della nostra Nazionale addosso. E lo farò nel campionato del mondo, così tutto il pianeta lo dovrà vedere, e dovrà dire caspita, lo avete visto? Quello era il gol più bello che sia mai stato segnato. E lo ha segnato un argentino.
In silenzio, come a suggellare quella decisione, il sole tramontò su Villa Fiorito. Diciassette anni, tre mesi, diciotto giorni e quattro ore prima di essere marcato, era nato il gol più bello del mondo.
2. Correndo sulla spiaggia col Narigòn
Quattordici anni dopo Pelusa stava facendo stretching, prima di andare a correre, quando gli dissero che era arrivato il Narigòn, l’uomo col nasone.
Non era stato un gran periodo, per il piccolo Indio: gli avevano perfino detto che sarebbe stato difficile per lui giocare ancora a pallone, dopo quella terribile malattia del fegato che aveva preso mangiando qualcosa di sbagliato.
Ma non avevano tenuto conto, i medici, del fatto che Pelusa era cresciuto danzando tra chiodi arrugginiti, scansando macchine e biciclette per inseguire la sua palla bitorzoluta: uno non sopravvive a Villa Fiorito per poi smettere col calcio in Spagna per uno stupido frutto di mare guasto. E lui si era messo sotto, e ora era quasi pronto.
Se ne era andato a Lloret Del Mar per respirare aria buona e allenarsi. Era gennaio e non c’erano distrazioni. Il suo preparatore, Fernando, aveva lavorato benissimo; d’altra parte, quando vedeva il piccolo indio un po’ impigrito, bastava ricordargli del Mundial che sarebbe stato da lì a tre anni per vederlo trottare come un puledro.
La telefonata era arrivata due giorni prima: il nuovo selezionatore, quello col grande naso che aveva preso il posto di Menotti, voleva vederlo e parlargli. E che vuole?, si era chiesto Pelusa. Forse, si era risposto, dirmi che la malattia al fegato non mi rende affidabile; forse vuol farmi capire che non intende chiamarmi, e che non devo fare polemiche sui giornali per il bene della Nazionale. Forse è meglio che non lo veda, pensò. Voglio tenermi almeno il mio sogno.
E invece adesso eccolo qui, alto e allampanato con quella proboscide in mezzo alla faccia, che guardava solenne Pelusa che era pronto per andare a correre in spiaggia. E Pelusa guardava lui, col petto in fuori e il mento in alto, come ogni volta che aveva paura. Stai andando a correre?, disse il Narigòn. E allora, hai una felpa per me? Vorrei farti compagnia. Questo è un pazzo, pensò il piccolo Indio. Un pazzo furioso.
Il vento tagliava il pomeriggio di gennaio, a Lloret Del Mar. La spuma si alzava dalle onde e disegnava figure, per chi si fosse messo a guardare. Ma il piccolo indio e il Narigòn non guardavano, correndo sul bagnasciuga: si inseguivano invece, senza guardarsi se non di sottecchi. Pelusa accelerò, per cattiveria; il Narigòn gli stette dietro con sforzo, gli occhi aggrottati e le guance che si gonfiavano e sgonfiavano come una pompa. Pelusa ebbe pietà e si fermò. Il Narigòn si lasciò cadere a terra, gli occhi sulla spuma, il cuore nelle orecchie.
Dopo un po’ disse: sai che cosa mi dicono, in giro per il mondo? Lo sai, tu? No, disse Pelusa. Che ti dicono? Dicono che nel settantotto non abbiamo vinto noi, ma il regime, dicono. Dicono che dovevamo uscire, che se si fosse giocato in qualsiasi altro Paese, il Mundial non sarebbe stato nostro. Dicono che in Sudamerica c’è il Brasile, e poi nessuno, e poi ancora nessuno, poi il Perù e l’Uruguay e poi noi. Questo dicono, in giro per il mondo.
Pelusa ascoltava e pensava ancora: quest’uomo è pazzo. Hanno dato la Selecciòn in mano a un pazzo. Però dentro sentiva anche tremare l’orgoglio, e la voglia di ricacciare in gola a tutti quelle parole che dicevano in giro per il mondo.
Il Narigòn distolse gli occhi dalla spuma e guardò in faccia il piccolo indio. Io voglio vincere il Mundial, disse. Lo voglio vincere in un Paese che non sia l’Argentina. Voglio dimostrare che non è vero che il Brasile, che l’Italia, la Germania e la maledetta Inghilterra, non è vero che loro e solo loro… Voglio fargliela vedere.
Pelusa aspettava. Voleva vedere il pazzo dove andava a parare.
Ma non posso vincere senza di te, Pelusa. Se devo vincere, la squadra in braccio la devi portare tu. E se due mani devono alzare la stramaledetta coppa, allora quelle mani sono quelle là, che tu tieni attaccate alle braccia.
Il vento di gennaio si fermò, sorpreso da quelle parole. Pelusa aspettava ancora.
Il Narigòn disse: tu sarai il mio capitano, indio. Il nostro capitano. Ti costruirò la squadra attorno, e noi campioni non ne abbiamo, lo sai: ma io ti costruirò attorno un vestito, perché tu, Pelusa, sei il miglior giocatore del mondo. E giuro su Dio che tu sarai anche il campione del mondo, e segnerai un gol, proprio tu, segnerai un gol che gli ricaccerà in gola tutte le loro risate.
Il gol più bello del mondo, mormorò Pelusa. E pensò che quello era un pazzo, sì, ma un pazzo meraviglioso. E che aveva ragione. La memoria gli riportò uno strano sapore di fili d’erba di Villa Fiorito, ma il vento trascinò via il ricordo.
Sì, disse sorridendo. Sarò il tuo capitano. E alzerò quella coppa, con l’aiuto di Dio. L’alzerò e te la darò da baciare, ma poi me la ridarai, perché il suo posto è nelle mie mani.
Il Narigòn annuì, si alzò in piedi e diede la mano a Pelusa: sembrava uno sbilenco Don Chisciotte in felpa e scarpe di tela, nel vento e nella spuma di Lloret Del Mar; ma il suo mulino roteava in un continente lontano, a tre anni e più di distanza.
Si rimisero a correre, inseguendo ognuno il suo sogno. Che poi, alla fine, era lo stesso sogno.
3. Quattro palleggi e un tiro al cielo
Pelusa arrivò nella Città Azzurra di giovedì. Come al solito gliel’avevano sconsigliato, ma che fai, non hanno mai vinto niente, dove ti vai a buttare pur di andartene dalla Spagna.
E lui, come al solito, aveva fatto di testa sua. E allora?, aveva pensato. Vado e vinco io. Ho sempre vinto, vinco anche là. E poi gli era piaciuta la faccia del dirigente, quello che aveva parlato con lui: silenzioso, gli occhi decisi. Un solo sorriso, e alla fine. Perché solo alla fine si deve sorridere, gli altri sorrisi sono finti.
Girando nella macchina coi vetri neri, stanco del volo e della lunga notte di attesa, Pelusa scoprì che nella Città Azzurra c’era già stato. Non fisicamente, ma come pensiero e come sogno: era su tutti i muri, disegnato sghembo, sugli striscioni appesi tra i balconi come lenzuola ad asciugare, perfino sulla strada, impresso nell’asfalto con gli occhi strizzati dal sole. E i suoi capelli, riccioli neri sintetici, in forma di parrucca in testa a ragazzini scalzi che rincorrevano palloni in discesa. Sono pazzi, pensò Pelusa. Questi sono pazzi.
Gli dissero che lo avrebbero presentato allo stadio, e lui si sorprese, ma perché, chiese, ci sarà tanta gente? Addirittura faranno pagare il biglietto, gli spiegarono. E io che dovrò fare? Dovrai salutarli, risposero. Solo dirgli ciao.
Salite le scale dal ventre della terra e arrivato su quella che sarebbe stata la sua erba, non credette a quello che vedeva. Era tutto pieno, settantamila paia d’occhi, settantamila bocche contorte in un solo urlo, con quel caldo, e col biglietto da pagare.
Lo guardavano, e lui guardò loro. Si innamorarono, e fu una lunga, difficile e bellissima storia d’amore che non finì mai. Pelusa gonfiò il petto e sembrò altissimo. Dalla tribuna gli arrivò un pallone, come un messaggio, come una richiesta. E il pallone andò docilmente ad accoccolarsi sul suo piede sinistro, addomesticato, tranquillo. Vent’anni dopo, ricordandolo, un meccanico in pensione disse all’intervistatore: dotto’, mi dovete credere, io l’ho visto con gli occhi miei, lui andava avanti e il pallone lo seguiva, gli andava appresso comm’a ‘nu cacciuttiello, come un cagnolino. Lui avanti, e il pallone appresso.
Pelusa palleggiò quattro volte, il rombo nelle orecchie che saliva. In quel momento sentì il cuore a casa, per la prima volta lontano da Villa Fiorito. E palleggiando pensò al Mondiale, di lì a due anni, e al Narigòn che gli consegnava la squadra e i suoi sogni, sogni uguali a quelli dei ragazzini che inseguivano il pallone in discesa, coi suoi capelli finti in testa. Anche per voi, pensò sull’ultimo palleggio: lo farò anche per voi, il gol più bello del mondo.
E affidato il pensiero al pallone, come a un piccione viaggiatore, lo calciò verso l’alto, con una parabola immensa e accorata. In alto, verso il cielo azzurro della Città Azzurra.
4. Due anni dopo, la palla del Negro
E fu così che dopo che furono passati cinquantacinque minuti, Hèctor Adolfo Enrique detto El Negro intercettò il pallone, che vagava inutile nella trequarti.
Diede un’occhiata attorno, mentre le maglie bianche si disponevano diligenti, ognuna al suo posto; per quanto riguardava le maglie blu, bastava individuare quella di taglia più piccola. Gli ordini del Narigòn erano stati chiari: non perdete tempo a inventare, ad arzigogolare soluzioni ingegnose. Non perdete tempo: trovatelo, e datela subito a lui. Hèctor El Negro sapeva che lui gli sarebbe venuto incontro, lo avrebbe indovinato anche se lo avessero bendato. Lui faceva così: in qualsiasi parte del campo, lo trovavi più vicino degli altri, come se avesse già visto la partita e se la ricordasse a memoria, come se la palla gli avesse parlato, senti un po’, allora mettiamoci d’accordo: io rimbalzerò due volte, la seconda volta un po’ storta perché c’è una zolla, e cadrò esattamente là; fammi trovare il tuo piede sinistro, e io ci sarò. Hèctor El Negro sapeva che quel piccolo, immenso figlio di una furba puttana aveva bene in mente dove la palla sarebbe andata.
Una volta, in allenamento, gli aveva detto: scommetto una birra che metto il pallone su una bottiglia di Coca Cola, piazzata dietro al palo, fuori dal campo; e che la calcio senza far cadere la bottiglia, e la palla gira e entra nella fottuta porta. Proprio così, mentre gli altri correvano e sudavano attorno al campo, per irrobustire i muscoli che servivano all’unico fine di dare la palla a lui. El Negro aveva sorriso, aveva scosso il capo e aveva detto: voglio vedere, questa la voglio proprio vedere. Ma niente birra, però, Pelusa. Io con te non scommetto, se hai un pallone in mezzo ai piedi. E, manco a dirlo, la bottiglia era rimasta in piedi e la palla si era fermata giusto cinque centimetri dietro la linea di porta.
El Negro non ebbe bisogno di aspettare: gli bastò vedere tre maglie bianche preoccupate convergere in un punto del campo a tre metri da lui, per circondare la camiseta blu di taglia più piccola. E, naturalmente, gliela diede. Un innocuo appoggio di tre metri, a cinquantacinque metri dalla porta, a cinquantacinque minuti dall’inizio della partita; cinque e cinque fanno il numero che c’era sulle spalle della camiseta. Il numero dieci. Quell’appoggio era l’assist per il gol più grande della storia del calcio.
Non era una partita qualunque, proprio no. E non perché fosse il quarto di finale del campionato del mondo di Mexico Ottantasei, proprio no. I due popoli erano diversi per natura, i ricchi europei biondi e colti e gli indios furbi e bruni; ma non era questo, il punto. Il punto era in due grosse isole e un pugno di scogli in mezzo all’oceano, un posto sconosciuto e inutile, nella follia di una decina di militari e in una questione di principio. I presupposti di un casino politicomilitardiplomatico, che aveva fatto decine di morti quattro anni prima; e che aveva fatto rimanere un ragazzo di ventidue anni dalle gambe storte e dal testone riccio davanti alla televisione in bianco e nero, a occhi sbarrati a guardare il ritorno in nave di tante casse piene di giovani argentini morti. Il ragazzo non aveva capito le ragioni, e non le avrebbe capite nemmeno se si fossero messi in dieci a spiegargliele parola per parola; l’unica cosa che gli era chiara era che quei ragazzi della sua età erano stati uccisi dal popolo ricco, biondo e colto d’oltremare. E che lui non ci poteva fare niente, se non vendicarsi con la sua arma, quella che il padreterno gli aveva regalato in enormi quantità: il talento di capire in anticipo la strada che la palla avrebbe fatto.
Cinque minuti prima che El Negro gli desse il pallone, su uno spiovente vano in mezzo all’area bionda, il piccolo indio ci era andato lo stesso, anche se il portiere avversario era alto quasi due metri e in più poteva usare le lunghe braccia e le mani guantate. Ci era andato perché in fondo non si sa mai, magari gli scappava. E trovandosi da quelle parti era saltato, con le forti gambe storte a fare da molla, ed era anche saltato alto: ma, pur calcolando i folti capelli e la perfetta scelta del tempo, avanzavano ancora le mani dalle dita lunghe e i tentacoli da polipo di Shilton, l’ultimo difensore. E che giustizia c’è, alla fine, pensò Pelusa, se alle regole di una natura matrigna si aggiunge quella degli uomini che dice che lui può usare le mani e io no? Se ci hanno rubato le nostre isole, tanto più vicine alla nostra terra che alla loro?
E Pelusa mascherò nel gesto del salto il piccolo pugno sinistro in mezzo ai capelli, e tanta grazia ci mise che nessuno se ne avvide a velocità normale, nemmeno Shilton, che da terra guardò la sfera magica rotolata lenta in fondo alla sua rete. Solo l’occhio ristretto a fessura di Fenwick, biondo stopper senza fantasia, malfidente e sospettoso, aveva visto il pugno di Pelusa sfiorare palla e capelli. E protestò e protestò, ma l’arbitro si era convinto ormai, e indicò il centro del campo mentre Pelusa pensava che a rubare ai ladri di isole non è peccato.
Questo solo cinque minuti prima che El Negro desse palla alla piccola maglia blu in mezzo alle maglie bianche. Cinque minuti prima della prima veronica, con la quale Pelusa si girò nella giusta direzione e inquadrò il suo obiettivo. Inclusa la suddetta veronica avrebbe toccato il pallone dodici volte, prima di entrare nel Mito; sempre con la stessa scarpetta.
Ecco, ce l’ha lui, disse il cronista argentino. Lo marcano in due. Fu vero, per la frazione di secondo in cui i due biondi europei credettero che lui sarebbe andato dalla parte in cui normalmente andavano i centrocampisti. Forse per quell’attimo non strinsero nemmeno le maglie della marcatura, perché una delle regole non scritte di questo sport vuole che uno, per forte che sia, tenti di ribaltare il gioco prima possibile; che, se è marcato, quell’uno si liberi della palla di fuoco che ha tra i piedi e la dia a quello libero. Perché è matematico, rifletterono: se siamo in due qui, ce n’è uno libero da un’altra parte, e il piccoletto lo cercherà.
Il piccoletto invece non cercò nessuno, in quella fase. Valutò più opportuno creare una superiorità, attirando al solito su di sé un paio di avversari per liberare poi un compagno al tiro. Ma doveva farlo con calma: il pallone doveva arrivare su un piede non ignorante, e non a un’immensa distanza dalla porta. Di piede non ignorante ce n’era solo uno, in squadra; Pelusa non lo avrebbe ammesso neanche in confessionale, ma sapeva che era così. Il solo piede degno di assist di quell’Argentina era il destro di Jorge Alberto Valdano Castellano, centravanti emigrante a Madrid; niente di epico, ma insomma. Il Dieci, allungando la falcata, entrò nell’altra metà campo lasciandosi dietro come se nemmeno ci fossero stati due dei tre che per primi gli si erano accostati, e lanciò un’occhiata a sinistra: Jorge c’era, aveva capito ed era scattato in verticale; ma c’era un problema.
Terry Fenwick capì che il Piccolo Argentino Bastardo avrebbe puntato la porta. Il fatto che i compagni abboccassero alla finta e rimanessero sul posto non lo sorprese: cinque minuti prima aveva visto il tizio segnare col pugno, il ladruncolo figlio di troia, figurati se lui ci sarebbe cascato. Mentre con la coda dell’occhio seguiva Valdano andare verso la porta, Terry osservò il nano col dieci, inseguito da una muta di difensori come una volpe nello Yorkshire; e come una volpe era furbo, l’aveva visto solo cinque minuti prima, ingannare tutti, compreso Shilton, ma non lui; perché Terry Fenwick veniva da Seaham, nella contea di Durham; posto di pescatori che affaccia sul Mare del Nord, dove la vita è dura e chi si fa fregare dai furbi è destinato alla fame. Pensò che il figlio della signora Fenwick non era un fesso, e non sarebbe stato ricordato dalla storia in quanto fesso. Sapeva che il nano, essendo una volpe, voleva attirare su di sé tutti i difensori inglesi, e poi scaricare su Valdano davanti al portiere. Lo capì solo lui, e strinse gli occhi diffidenti; e si piazzò esattamente sulla traiettoria dell’ipotetico passaggio del nano a Valdano. Comunque andrà a finire, pensò, tu a Valdano la palla non la dai. E così fu.
Niente, pensò Pelusa in una frazione di decimo di secondo: quel maledetto Fenwick non si sposta. Valdano so che c’è, ma non lo vedo: e se non lo vedo, non gliela posso dare. Non mi resta che continuare.
Il pallone attaccato al sinistro, un tocco a uscire e uno a rientrare, fatti fuori altri due. Sentiva il fiato sul collo, il suo cuore martellargli le orecchie, bum, bum, bum. Parte sulla destra il Genio del calcio mondiale, disse il telecronista argentino al suo popolo. Fu l’ultima frase di senso compiuto che riuscì a pronunciare, incantandosi su quel concetto per i secondi che seguirono: Genio, Genio, Genio, Genio… non disse altro. L’ostile perché geloso pubblico messicano cominciò a far salire un brontolio che diventò un tuono, ma Pelusa non lo sentiva. Aveva rinunciato a darla a Valdano dalla porta che Fenwick teneva chiusa, e aveva capito che aveva un’unica possibilità di finire l’azione: finirla da solo.
Hèctor El Negro, rimasto ormai quaranta metri indietro, scosse piano la testa. Se ne va da solo, pensò. Se ne va da solo, quel piccolo figlio di buona donna. Se ne va da solo, cinque minuti dopo aver segnato un gol, in un quarto di finale della Coppa del Mondo; se ne va da solo, Dio, ascoltami se non hai di meglio da fare, Dio, aiutalo tu.
Fenwick si rese conto che il maledetto nano non avrebbe più potuto dare la palla a nessuno. Voglio vedere adesso che fai, pensò. Ne hai altri due davanti, e qui ci sono io.
Pelusa ne aveva altri due davanti. Uno gli sbarrava la via diretta per la porta, un altro gli avrebbe impedito di andarsene a destra per poi fare un cross. Il maledetto Fenwick aveva capito tutto, e non si era mosso dalla traiettoria, quindi se anche avesse tentato un passaggio al centro per Valdano non ci sarebbe stata nessuna possibilità. Che faccio?, pensò Pelusa. Mamma, che faccio?
Sotto gli occhi ridotti a due fessure, Fenwick strinse le labbra. Vieni, bello; vieni dalla mia parte. Vieni qui, che ti azzoppo. Tu sei la volpe, io sono il grosso setter che ti azzannerà. Chiedi in giro, nano, come finiscono sempre le cacce alla volpe, nello Yorkshire.
Pelusa seppe che non c’era altra strada che tentare la sorpresa. Era una vita, che tentava la sorpresa. Tutto il suo calcio era basato sulla sorpresa. Ti aspetti che tiri di destro? E io metto il sinistro dietro la gamba, e calcio come se avessi usato l’altro piede. Ti aspetti che io tiri forte sul palo più vicino? E io tiro piano piano, sull’altro palo. Ti aspetti che vada all’esterno, cercando il mio piede? E io me ne vado all’interno e ti faccio una rabona sotto il muso. Ti aspetti che passi la palla a un compagno vicino? E io cerco quello libero, più lontano. Nella calda città di mare dove giocava, il posto più argentino del mondo fuori dall’Argentina, lo sapevano tanto bene che cominciavano a urlare prima che la palla gli arrivasse, già quando i compagni con la maglia color del mare alzavano lo sguardo per cercarlo. Datela a me, gli diceva Pelusa mentre si cambiavano negli spogliatoi. Datela a me, e ci penso io. La sorpresa, pensò Pelusa. Che ti aspetti, Fenwick? Che io ti eviti? E invece eccomi qui, Fenwick: vengo proprio nella tua bocca. Vediamo che fai.
Fenwick quasi non ci credette, quando vide il nano convergere dalla sua parte. Viene qui, si disse. Alla fine, viene qui. Non se lo aspettava, aveva pensato che avrebbe scelto un’altra soluzione, andarsene all’esterno e crossare per la testa di Valdano; a quel punto lui avrebbe avuto gioco facile, anticipando il lento centravanti in maglia blu. E invece viene qui, verso di me. La frazione di secondo, forse uno o due centesimi di sorpresa e la difficoltà di mollare la traiettoria prevista per il passaggio fecero ritardare il terribile calcio che sferrò al nano, al limite dell’area: meglio una punizione dal limite che metterlo da solo davanti alla porta. E poi magari lo azzoppo, e non se ne parla più.
Pelusa vide partire il sinistro di Fenwick verso la sua caviglia. Non era il primo, e nemmeno il millesimo calcio che partiva verso la sua caviglia. Li aveva sempre sfidati e battuti, i calci. Il suo gioco portava la furia negli occhi e nei cuori neri dei difensori, che non gli perdonavano l’immenso talento. A volte lo prendevano, ma era molto raro. Nella mente passò con la sua ala fredda il fantasma di Goicoechea, il macellaio di Bilbao, l’uomo che irriso per l’ennesima volta gli aveva fratturato il malleolo con un terribile calcio da dietro nell’ottantatre. Ma fu solo un attimo. Il piede di Fenwick non era svelto come il suo cervello. Lo saltò, e scansò anche la mano che l’europeo aveva allungato nel disperato tentativo di afferrare la sua camiseta blu. Ora c’era solo il portiere. Eccomi, Shilton. Di nuovo soli, io e te.
Pelusa fermò il tempo, sull’urlo del telecronista che disarticolava la parola Genio, su Fenwick che scuoteva il testone, sul Negro che lo guardava a bocca aperta da sessanta metri, sul biondo Butcher che arrancava dietro di lui. Fermò il tempo nello sguardo che incrociò con Peter Shilton, che copriva con la traiettoria della sua perfetta uscita la luce della porta. Pelusa fermò il tempo, perché stava pensando al suo fratellino Hugo, detto il Turco.
Era successo questo: sei anni prima, e prima delle isole invase e delle casse con i ragazzi argentini al porto, prima dell’Europa e del sogno Mundial, prima di tutto insomma, Pelusa era andato a Wembley, il tempio del calcio. Ci era andato in prova nella nazionale che poi sarebbe diventata di sua esclusiva proprietà, per un ciclo di amichevoli; l’Inghilterra era forte e seria, l’Argentina era disordinata e geniale, proprio come adesso. E insomma, era successo che a Pelusa avevano dato una palla più o meno come quella del Negro, e lui si era fatta una bella sgroppata per tutto il campo, più o meno come questa. Arrivato davanti al portiere, più o meno come questo, aveva cercato di infilarlo sull’uscita, più o meno come questa; e la palla era uscita di un soffio. La sera, al telefono dall’albergo, il piccolo Turco aveva reclamato la cornetta dalla mamma che consolava il figlio, e gli aveva urlato: coglione, sei un coglione! Pelusa aveva chiesto perché, e il piccolo Turco, undici anni appena compiuti, gli aveva spiegato che non c’era spazio per il pallone, con un’uscita del portiere così. Che l’unico modo era andarsene in dribbling a destra, e mettere dentro il pallone col piede sbagliato.
L’unico modo.
La testa di Pelusa fermò il tempo, e pensò al piccolo Turco che era diventato grande e forte, e che stavolta non gliel’avrebbe perdonata. Allora si disse, Pelusa: Turquito, hai ragione. Questo è per te. E se ne andò verso destra, lasciando Shilton seduto a terra, nella consapevolezza che il terribile Butcher, difensore dell’Ipswich Town, era l’ultimo cane della muta che lo inseguiva. E lo teneva proprio sul suo piede destro.
Butcher accompagnava il maledetto nano, correndogli al fianco. Che vuoi fare, me lo spieghi che vuoi fare? Non penserai di fare un gol così all’Inghilterra, nel quarto di finale della Coppa del Mondo? Non oserai credere di fare una cosa del genere a noi, che il calcio l’abbiamo inventato? Ecco, adesso hai superato Fenwick, hai sbandato ma hai ripreso l’equilibrio. Ecco, ora hai superato Shilton, lo hai messo col sedere a terra. Ma dovrai tirare di destro, per forza. E io ti affondo una bella entrata proprio su quel piede, così tirerai fuori, com’è giusto. Perché nessuno fa un gol del genere in un quarto di finale del Mondiale, bello. Non all’Inghilterra. Non con me in squadra. Chiuse gli occhi, e affondò il tackle sul piede destro di Pelusa.
Dopo Goicoechea, dopo i mesi a guardarsi il gesso chiedendosi se sarebbe mai più tornato come prima, dopo la paura e la disperazione, Pelusa non aveva certo cambiato il suo gioco. Il pallone per lui era questo, e non avrebbe saputo giocare altrimenti. Però una cosa era cambiata: ora sentiva il movimento da dietro, senza guardare. Intuiva una variazione dell’aria, un cambiamento nel ritmo del respiro dell’avversario che lo inseguiva. Capiva il momento dell’entrata, insomma. E in quell’istante, stremato dalla corsa, dalla mancanza di respiro, annebbiato dalla stanchezza e dall’altura, sentì che Butcher aveva deciso di chiudergli la strada del piede destro, del quale peraltro non si fidava e che usava solo in condizioni disperate. E allora pensò: Turquito, fratellino, perdonami ma non posso fare quello che mi hai suggerito. Non del tutto. E appoggiato il destro a terra, offerto all’inutile disperata entrata di Butcher, accarezzò il cuoio col sinistro. Un’ultima volta. La dodicesima.
Il telecronista argentino aveva cambiato la parola: da “Genio” era passato a “c’è”, ripetuto tre volte da Shilton a terra fino al dodicesimo tocco. Ora cambiò di nuovo, e disse: “gol”. Con dodici “o”. Poi, piangendo: “voglio piangere, Dio santo. Viva il calcio!”
El Negro aveva cominciato a correre, da sessanta metri, nel momento stesso in cui aveva visto Fenwick tentare di abbrancarlo con la mano senza riuscirci. Correre in Messico non era facile, l’aria era strana e ti spezzava il fiato; né El Negro pensava di dover partecipare all’azione, ormai. Ma aveva cominciato a correre, perché aveva una cosa urgente da dire a Pelusa dopo che avesse segnato, perché El Negro non aveva dubbi che la palla sarebbe finita in fondo alla rete, che quello era il gol più grande e meraviglioso della storia del calcio. Perciò si mise a correre, andando verso la bandierina del corner, dove aveva un appuntamento con il Gigante nano.
Senza fiato, urlando senza voce, Pelusa prendeva aria dalla bocca spalancata in mezzo ai compagni che lo sotterravano d’amore. Il telecronista piangente comunicava all’Argentina che aveva visto il Dio del calcio scendere sulla terra. I messicani e gli argentini urlavano al cielo la propria meraviglia. Dio, quello vero, guardava sorridendo e scuotendo il capo, congratulandosi con Se Stesso. Districatosi dall’abbraccio, Pelusa si trovò faccia a faccia col Negro Enrique che gli parlava. Che?, gli disse.
Hèctor Adolfo Enrique detto El Negro ripeté: con quella palla che ti ho dato, Pelusa, non avevi che da metterla dentro.
E Pelusa considerò che era vero. Era proprio vero”.

SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
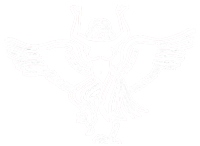

Devi essere loggato per commentare Login