A novant’anni dalla morte, occorre conoscere la maestria di un poeta che seppe raccontare la vita di quegli anni come pochi altri. Ricordando che ci fu, ma poco chi fosse, Ferdinando Russo a novant’anni dalla morte è appiattito nell’esiguo cassetto dei poeti dialettali sotto l’ingombrante fascicolo di Salvatore di Giacomo. La sua fu invece una figura tridimensionale di riuscita prova, nel giornalismo e in un’arte narrativa che si sciolse, nel magico momento tra due secoli, con efficacia in versi e in prosa.
Se Borges lo avesse conosciuto, ne avrebbe raccontato come di un Evaristo Carriego più compiuto. Se Benedetto Croce, al tempo ch’erano entrambi vivi, gli avesse rilasciato un certificato critico più generoso, Ferdinando Russo non avrebbe aspettato gli attestati – a loro volta oggi sbiaditi – di Pasolini e Bernari per una laurea poetica che, come quella accademica, lui oltrepassò sul campo.
A differenza del di Giacomo, di Bovio e di tanti letterati napoletani prima o dopo di lui, per Russo vita e opere restano inseparabili. Se non fosse stato d’una bellezza saracena, poco o nulla avrebbe cantato d’amore. Se non avesse schiaffeggiato un guappo conquistando il rispetto delle consorterie malandrine, poco o male avrebbe scritto di camorra. Se avesse evitato certe infrequentabili bettole, non sarebbe diventato un esemplare cronista di “nera”. Mentre di Giacomo sognava in poltrona, Russo trasognava a passeggio; se il primo distillava endecasillabi dal lavorìo del cuore, giungevano al secondo da un orecchio pronto a coglierli già fatti nelle voci di strada.
Si definiva e lo qualificarono verista, ma fu per metodo più che per scopo: contestò a di Giacomo la descrizione di un carcere perché lo raccontava come chi non ne ha mai visto uno. Riscosse le prime fortune col poemetto “‘O cantastorie”, ma narrando le vicende dei paladini francesi come le avrebbe esagerate, con lingua e animo napoletano, uno dei “patiti” che le ascoltavano sul Molo e presi da fervore davano talvolta mano ai coltelli. Descrisse la Napoli più sfigurata che salvata dal Risanamento come e meglio di Matilde Serao. Ne scrisse per lei e per il marito Edoardo Scarfoglio, coi quali fondò Il Mattino nel 1892 e li difese nei giorni della controversa inchiesta ministeriale Saredo del 1900. Sapeva di abbracciare una causa opaca ma nell’onesta certezza di farlo per Napoli, che l’unificazione nazionale mal condotta aveva declassata da Capitale a capoluogo quattro decenni prima, alimentando la camorra e trascinando alla miseria tanta parte di piccola borghesia.
Inventò, o trasse ai dizionari, due vocaboli tuttora correnti in italiano come “scugnizzo” e “macchietta”. Proprio per una “macchietta” che rimpiangeva re Francesco fu accusato di borbonismo e finì dal giudice istruttore, il quale lo prosciolse più in virtù d’intelligenza che del codice. Degli scugnizzi raccontò la sciagurata infanzia e gli implacabili destini di “gente ‘e malavita”. Mentre ciò faceva fu tuttavia protagonista vagheggiato di salotti e caffè, per il periodo più felice in compagnia di Gabriele d’Annunzio che lo elesse fra gli assidui amici nel soggiorno vesuviano. Don Ferdinando serbò e girò a Francesco Paolo Tosti i versi di “‘A vucchella”, che il Vate aveva improvvisato in napoletano e divenne, con le note del musicista abruzzese, la prediletta canzone di Enrico Caruso. Anche Russo affidò poesie alle cure di compositori celebrati come Mario Costa, che firmò la musica di “Scétate!”, bella come quella di “Era de maggio” concepita per il “rivale” di Giacomo. Fu un’epoca d’oro che si dissolse con la prima guerra mondiale, cui il filosofo Adriano Tilgher attribuì l’effetto disastroso di un “diluvio” per la canzone napoletana. La guerra soffiò sui sentimenti di Russo, sull’impresa discografica affidatagli dalla tedesca Polyphon, sulla sua rivista d’arte Vela Latina (una “idea piena di sole”) dove aveva ospitato i futuristi.
Sentendosi accantonato non uscì più la sera ma non andava a letto presto: le notti trascorrevano in un labile sonno inframmezzato dal lavoro e le ultime fatiche rimasero incompiute. Remoti i suoi entusiasmi al Mattino, scomparso Scarfoglio e invecchiato d’Annunzio, Russo si sentì solo coi ricordi e li filtrava con intense suggestioni dal libro che aveva fra le mani prima di morire, il Cirano di Bergerac nella traduzione di Mario Giobbe (ancora riproposta dalla Bur), di cui gli piaceva recitare i passi a memoria. Collaborava al quotidiano Il Mezzogiorno con qualche poesia e due rubriche minori non fosse stata sua la firma: “Chiacchiere al caffè” e “Piccola posta”.
Morì a 61 anni domenica 30 gennaio 1927 dopo ventiquattr’ore di agonia. Sbagliò a credersi dimenticato, perché ai funerali il concorso di folla fu tale che per un poeta non s’era mai visto. Editori e librai osservarono un giorno di lutto. Il “rivale” di Giacomo pubblicò una lettera al «fratello mio generoso e buono, sincero amico, eterno fanciullo in cui sorride l’eterna Poesia». E «appiè del lettino su cui riposi – scrisse – io piego le mie ginocchia». Lasciava abbozzata una versione del “Candelaio” di Bruno rigirato in napoletano, che secondo lui ne era l’idioma originale storpiato da un copista secentesco.
Una ex sciantosa sposata d’impeto anni prima, con cui aveva vissuto solo la travagliata luna di miele a Parigi, riapparve accampando diritti. Le carte di Ferdinando furono disperse e i molto amati quadri messi quasi tutti all’asta.
Richiudiamo novant’anni dopo il cassetto qui frettolosamente frugato, nella speranza che Napoli lo riapra con la cura dovuta al figlio che la illustrò.
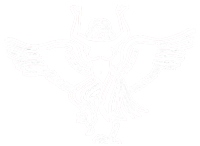



Devi essere loggato per commentare Login