Identità
IL DOCUMENTO STORICO / Così Gennaro Pasquariello si raccontava: “Ho anche io i miei ricordi”



“Ho anch’io i miei ricordi” di Gennaro Pasquariello (Napoli, 8 settembre 1869 – Napoli, 26 gennaio 1958) – di cui ieri ricorreva l’anniversario della nascita – è un articolo scritto nel lontano 1938 (per la rivista mensile del Corriere della sera “La lettura”), in cui egli ripercorse i punti più salienti della sua vita. E’ il primo “pezzo” raro e prezioso che ci offre un appassionato quale Domenico Livigni che inizia con questa chicca preziosissima una collaborazione con Identità Insorgenti che ci auguriamo lunga e proficua. Buona lettura!
Illustrissimo signore,
rispondo a volger di posta alla vostra pregiatissima lettera perché, sia detto tra noi, non sono solito
lasciar scappare le buone occasioni e, nel contempo, voglio esternarvi tutta la mia riconoscenza per le espressioni gentili, indubbiamente immeritate ma gradite moltissimo. Da parte vostra è stato pensiero particolarmente amabile invitarmi a “raccontare la mia vita”, ma a me fanno paura i lettori – sono forse io una stella? Una diva? Un Taylor o, almeno almeno, uno Stawinski qualunque? Umile figlio del popolo, per grazia di Dio, ho fatto fortuna nel contesissimo campo di una tipica competizione artistica, schietto e sensibile quale è quello della canzone napoletana, e, per rendermi interessante agli occhi del pubblico, non saprei inventare episodi comici o drammatici, vicende tragiche con relativi interventi di “gangsters” o di donne fatali, e tanto meno lotte cruenti e logoranti per accalappiare la celebrità. La mia vita è stata, ed è, serena, prosperosa, quattrinosa. La fortuna, bontà sua, mi ha costantemente assistito, forse perché ho saputo accoglierla con tranquilla fiducia; le scritture mi sono piovute l’una dopo l’altra; il pubblico mi ha sempre voluto bene…
Romanzetti d’amore? Quelle sì – chi è senza peccato scagli la prima pietra! – ma è prudenza dimenticarli, perché la mia illustre consorte mi farebbe pagar cara la confessione di scappatelle pazientemente nascoste. Non voglio correr rischi in famiglia: litigare con mia moglie e con mio figlio che, se non lo sapete (ma ve ne parlerò) è un valoroso direttore d’orchestra.
Detto questo, potrei ringraziarvi illustre amico, e porgervi i miei migliori saluti, ma non avrei soddisfatto al gentile interrogativo e, piegando alla vostra volontà, mi accingo a riassumere in brevi righe il roseo romanzo della mia vita, non senza avervi presentate mille e mille scuse per la scarsa pratica acquistata nel ricostruire documenti del genere.
Comincerò dalle generalità, come pel di censimento: sono nato a Napoli nel 18…(macchia d’inchiostro) da Giuseppe Pasquariello e da Maria Catello, napoletani tutti e due. Mio padre era negoziante-sarto e vendeva abiti a serie. Anche mio zio tagliava cappotti e “doppiopetti”, ed entrambi avevano deciso del mio avvenire, designandomi a loro successore. Ma il papà propone ed il figlio dispone!
Fin da giovanotto detti evidentissimi segni di avversione per l’ago e le forbici, denunziando spiccata
tendenza a cantare canzonette napoletane, in piena fioritura in quegli anni beati. Lavoravo senza entusiasmo zufolando motivetti di attualità e carezzavo nel mio cuore il sogno di poter, un giorno, calcare le scene. Avrei avuto successo? Una segreta voce rispose affermativamente, ed i battimani dei compagni, che, quando accennavo qualche canzoncina, stavano ad ascoltarmi attenti ed ammirati, mi incoraggiarono.
In quell’epoca, la “periodica” era di gran moda. Partecipavo ogni sera, si può dire, a quelle tipiche
riunioni familiari dei salotti piccolo-borghesi, che restano ancora oggi il ricordo dolce della mia vita di ragazzo. C’era obbligo da parte dei convitati dotati di esibirsi nei ruoli più strani e fare sfoggio di
virtù più o meno autentiche: la solita ragazza al piano, il solito professore di ginnasio declamatore di aulici versi, il chitarrista o il mandolinista, la cantante che aspirava agli onori di Gilda o di Violetta…ed i non meno soliti sciocchi giuochi di società. Io canticchiavo, ma ero ascoltato con attenzione, con interesse. I primi applausi mi trascinarono come in paradiso. Mi sentii beato.
Orgoglioso del mio primo successo, orgoglioso di essere ricercato, adulato, pregato, più che mai annoiato di dover tornare ogni mattina alle mie forbici ed ai miei aghi, decisi di saltare la barriera, mi feci coraggio, abbondonai il negozio ed andai per la mia strada. Strada assai stretta, a giudicare dalla prima scrittura in un localino (il caffè Allocca) posto all’angolo di via Costantinopoli (una sala lunga, grigia e soffocante, pochi tavoli in fila, una pedana grande quanto una cattedra, un pianoforte e dei buoni gelati).
Paga: tre lire giornaliere. O’ pumpiere, Uocchie ammennola, in gran voga allora, decisero del mio avvenire. Rotondetto come un vaso cinese, sbarbatello e paffutello, sembravo piuttosto tagliato per
le canzoni comiche, ma sapevo trasformarmi, far dimenticare il mio fisico, quando in me cantava il cuore e la melodia mi trascinava. Le ragazze mi sorrisero. Il pubblico mi prese in simpatia, passò la voce…
Venne a sentirmi Davide Petito (fratello del celebre Pulcinella Antonio Petito), e mi scritturò in qualità di generico nella sua Compagnia di prosa dialettale che razzolava da un paese all’altro, precorrendo il Carro di Tespi, ma senza fortuna. C’era miseria per tutti, e sarei morto di fame se mio padre non mi avesse aiutato con qualche rimessa postale. Si era placato. Aveva capito che non avrebbe potuto costringermi a vestire manichini ed a vendere tagli di stoffe ai provinciali.
Tuttavia ero nei guai, e vi lascio immaginare con quanta gioia accolsi la proposta di Don Gennaro Pantalena, il quale mi volle con sé al Nuovo. Famoso il teatro napoletano (distrutto quattro anni or sono dal fuoco), famoso il Pantalena. I critici mi dedicarono qualche attenzione, e Edoardo Scarpetta, il più illustre e fortunato attore di quei tempi, mi fece l’onore di offrirmi una scrittura nella sua formazione, per riesumare, disse lui, la vecchia maschera del buffo barilotto (nel senso dialettale, barilotto vuol dire pingue, ed io rispondevo pienamente al fisico del ruolo); ma rifiutai perché Scarpetta, assai poco generoso nelle paghe, era troppo severo, se non tiranno, con i comici.
Anche Leopoldo Mugnone mi onorò in quel tempo della sua attenzione, proponendomi addirittura di debuttare nelle opere buffe. L’insigne maestro mi voleva sinceramente bene e sognò per me un successone. Anche a lui dissi di no, perché avevo paura di affrontare un compito di tanta responsabilità; ed anche perché, dopo due anni di anonimato, aspiravo a liberarmi dalle briglie del capo-comico ed essere io, io solo.
Non mi fu difficile ritrovare la mia indipendenza, in quell’epoca fortunata del varietà. Avvertendo per istinto che avrei avuto fortuna, tornai con trepida ansia alle canzoni, debuttai tremando e, da quel tempo Piedigrotta e Pasquariello sono (posso dirlo?) una cosa sola.
Riassumerò ora gli avvenimenti milanesi. La prima volta che mi esibii a Milano fu al Varietà Unione, scritturato per un mese dalla vedova Verri con la ricca paga di diciotto lire giornaliere. Il debutto fu un vero fiasco. Neanche un applauso. Rientrai tra le quinte scoraggiato e mi sentii più che mai avvilito quando, più tardi, l’impresaria mi intimò l’ultimatum: “Potrei protestarvi su due piedi. Giovanotto, voi non sapete far ridere neanche le galline, ed il meglio che vi resta da fare è tornare a casa. Vi terrò ancora dieci giorni con la paga ridotta di otto lire, per darvi tempo di trovare lavoro e, poi, dietro front”.
Non drammatizzai. Mi resi conto che ai milanesi, non avvezzi al dialetto napoletano, era sfuggito il significato delle mie canzoni, e mi feci in quattro per farmi capire. Come fu, come non fu, in quei dieci giorni mi combinai il pubblico, e la illustre signora Verri mi fece l’onore di rimettermi in paga, elargendomi, per giunta, un pranzo gratuito giornaliero (allora c’era l’obbligo di consumare i pasti nel ristorante del teatro). Ero stato scritturato per trenta giorni. Restai all’Unione tre mesi e mezzo e seppi conquistarmi anche la simpatia dei camerieri, che andavano a gara per servirmi, permettendomi di soddisfare le tiranniche esigenze del mio stomaco. Feci insomma come il cammello: a mezzogiorno larga provvista ed a sera un caffè e latte. Fu forse allora che ebbe origine la mia fama di avaro.
Dal Morisetti (chi lo ricorda?) al San Martino, all’Eden, all’Apollo, al Puccini, all’Excelsior, al Trianon, di stagione in stagione la mia amicizia con i milanesi divenne sempre più stretta, ed i miei ricordi sarebbero tutti di color rosa, se, alcuni anni or sono, in un cinema rionale, non fossi stato derubato dell’orologio e della catena d’oro, data, questa, che resta memorabile nel calendario delle mie poche disavventure. Feci il finimondo. Ricorsi alla Questura. Urlai. L’impresario finì per indennizzarmi del danno, e l’accusa di avarizia trovò sempre più fertile terreno. Avaro? Lasciai dire, perché prudenza, economia, previdenza non disonorano nessuno. E poi il ritornello della mia avarizia è diventato oggi un motivo reclamistico, come l’impenetrabilità di Greta Garbo e le diecimila innamorate di Clark Gable. Il pubblico ci si diverte, mi vuol bene lo stesso, tutto procede, dunque, per il meglio.
Ma vogliamo spiegarci una buona volta, per sempre, ora che siamo a quattr’occhi? Che cosa è questa mia avarizia? Sperperare non è mai stato il mio genere. Vado orgoglioso di non aver mai firmato una cambiale e di non aver mai prestato cento lire ad un amico insolvente. E poi, qua si tratta di ragionare. Putacaso, l’Altissimo non mi avesse mai concessa la forza di lavorare, il pubblico mi avesse un brutto giorno fischiato ed io non fossi stato previdente in gioventù, sarei stato costretto a mendicare un posto di portaceste. Col mio sistema, invece, un gruzzoletto ce l’ho sempre avuto, ed ho potuto far la voce grossa con gli impresari.
Comunque tornando a noi, mai dimenticherò una famosa sera del 1930 in cui tutta Napoli accorse ai Giardini reali per la Sagra della canzone ideata e promossa da Filippo Criscuolo. Nel vecchio repertorio vennero scelte, con fine discernimento, alcune decine di canzoni che riascoltammo e cantammo con un senso acuto di gioia misto a rimpianto. Alla Sagra arrise un successone. Ai ritornelli di alcune canzoni fece eco il pubblico. Bissai, trissai Marechiaro e A Serene, e Nicola Maldacea nelle vesti femminili di Lilì Gangi, fece sbellicare il pubblico dalle risa. A proposito di Marechiaro, che Francesco Paolo Tosti, come narra la storia, portò trionfalmente agli onori della Corte d’Inghilterra, ricordo che l’illustre maestro mi invogliò a passare la Manica, e mi lanciò in un’avventura che mi fece tremare le vene ed i polsi. Peraltro, gli Inglesi mi capirono, mi applaudirono ed io tornai in Italia trionfante e felice, dopo di aver fatta la diretta conoscenza di quell’ignobile “tubo” che è la Metropolitana.
Che altro ho da dirvi? Non mi resta che raccomandarvi mio figlio, Mario Pasquariello, che ha studiato al Conservatorio e – ve ne do la mia parola d’onore – è un direttore di vaglia. Lo sentirete, spero, a Milano, e mi darete ragione. Perdonate a papà Pasquariello questa variazione sentimentale ed abbiatemi con la più viva amicizia, vostro.
Gennaro Pasquariello
(da “LA LETTURA”, A.XXXVIII, N.12, 1 DICEMBRE 1938)



SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
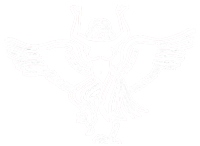

Devi essere loggato per commentare Login