Identità
IL RACCONTO / Rampe, gradini, calate, cupe: percorrendo a piedi le rughe di Napoli



di Maurizio Amodio
Per aspera ad astra…
Cupe, rampe, pendini, gradoni, calate, pedamentine, pallonnetti…
Le rughe scavate sul volto di Napoli hanno nomi verticali e sembrano ferite.
La tela nuda della città è fatta di gradini intagliati nella spugna gialla e umida del tufo e lastricati col grigio della lava vesuviana.
Qui tutto è storto, sghembo, obliquo.
Napoli non la vedi con gli occhi, la senti con le piante dei piedi.
Popolo di quadrumani, qui da sempre non facciamo altro che arrampicarci, avanzare passo a passo, appenderci, arrancare.
Salita Pontecorvo, Sant’Antonio ai Monti, Rampe Brancaccio, Petraio, Calata San Francesco, Gradini Tasso, Gradonate del Fosso, Santa Maria apparente, Salita Villanova…
Alcune hanno nomi tetri, memori di storie di sangue e assedi, come Cupa Lautrec; su altre, scrittori come Luigi Incoronato si sono mischiati alla folla stracciona di San Potito; al Pallonetto Santa Lucia, Marotta raccontava i miti greci ai pescatori e ai venditori di luna.
Qualcuno ne ha contate quasi duecento, di scale. Sono il nostro scheletro. E le conosce solo chi cammina a piedi, allenandosi quotidianamente nell’arte delle discese ardite e le risalite.
Questa è una storia di cosce forti e ginocchia consumate.
La dominavo a falcate, Salita Cacciottoli, a diciassette anni, quando era veramente pericolosa, in meno di un quarto d’ora dall’Olivella, passando sotto il lugubre fascio littorio del ponte del Corso, fino al panorama di Piazza Leonardo, sotto casa di Giancarlo Siani e Via Girolamo Santacroce,
impaziente di gettarmi fra le lentiggini di una ragazza bellissima e triste.
Salire era un rito misterico che trasformava ad ogni passo e lassù in cima eri un altro, eri adulto, eri uomo. Perchè con le piante dei miei piedi ricalcavo le linee di una storia scritta molto prima di me, da altri innamorati, scavando più profondamente negli antichi solchi incisi sul viso della città,
in un microcosmo senza macchine e motorini, dove i pure i suoni sono antichi.
Quelle rughe percorse da sciami di contadini che coi cesti in testa scendevano “giù Napoli” a vendere aglio, broccoli e cerase del Vomero, colando a valle come rivoli, torrenti, ruscelli umani che per secoli hanno scavato, solcato, intagliato la roccia morbida, plasmando i connotati della città, dandole senso, fisionomia, significato, sono la storia mai scritta della città. La storia popolare,
della gente comune, senza titoli e senza penna.
Che dal mare prende solo una carezza di sale e se la spalma in faccia prima di iniziare la risalita.
Quanti milioni di passi sulle stesse pietre, quanti sguardi gettati lontano, a cercare di scorgere bastimenti appena partiti pe’ terre assai luntane, a leggere il cielo e i venti, quante lacrime versate. E quanta fatica. Le storie di Napoli stanno spalmate su tutti questi gradini. Percorrerli significa
prendersele dentro, assorbirle e perpetuarle.
Se vuoi capire Napoli, devi consumarti le suole delle scarpe, non certo arrivare comodamente in taxi davanti a uno dei suoi tanti belvederi. Solo Lisbona le somiglia un po’, con le sue calçade e i suoi miradouros. Questa è una città iniziatica. Ovunque, non solo a Cappella Sansevero.
Metropoli di funicolari, qui è tutto un brulicare di tortuose linee verticali, una caracollante ragnatela di equilibrismi presepiali di volti affannati e sguardi che s’incrociano e si dicono “Coraggio, ce l’hai quasi fatta”.
Ed eccola, la signora Ava, quarantenne della Concordia, bellissima e perennemente struccata, scigliata ed elegante come solo una donna del sud sa essere. Mi fermo a guardarla. All’ultima rampa
di Santa Caterina, si ferma un attimo e poggia a terra le buste della spesa.
La figlioletta la guarda preoccupata: “Mamma, che c’è?”. Lei porta le mani dietro i reni e inarca la schiena, rivelando un pancione da ultimo mese: “Aspè, Ninuccia. Mammà sta stanca e ripiglia un poco fiato”.
Poi la smorfia di dolore si dissolve in un respiro imbevuto di futuro. Guarda il pancione e poi la figlia. E sorride: “Mò che saliamo a casa, ci mangiamo le noci. Così la sorellina tua nasce più forte. Già sta tirando certi calci…”
“Mamma, dopo le apro io le noci. Tu non ti devi stancare”
Ci stanchiamo da secoli, piccerè. Per questo siamo così belli.
(foto: Pendino Santa Barbara, 15/10/2019)



SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
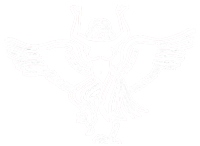

Devi essere loggato per commentare Login