Identità
Trionfi e riti nel segno dell’identità: la Cantata dei Pastori secondo Minervini, nel 1954



Dal Fujdoro (fascicolo 7-8 1954) un pezzo di Roberto Minervini su uno spettacolo della nostra tradizione: La Cantata dei Pastori.
Per la prima volta, quest’anno, una sola ribalta di Napoli ha acceso le sue luci per la famosa Cantata dei pastori rappresentata per due secoli e mezzo, puntualmente, dal Natale all’Epifania e dal popolo considerata il rito numero uno di quel periodo. E poiché si tratta di un rito singolare, paradossale, giocondo e festoso, conviene forse, illustrarlo e, come possibile, anticiparne la storia, quale contributo a quella, ancora da fare, di tutto il teatro partenopeo.
Indice
La cantata dei pastori: spettacolo sacro e profano
Sacra ed insieme, profana, la spettacolosa rappresentazione, i cui principali elementi erano costituiti dalle enfatiche declamazioni, dal canto, dalle danze e dalle farsette improvvisate, recitate a braccia, aveva lo scopo di rievocare e celebrare la nascita di Gesù. Si avviava, si, per un binario di mistiche e talvolta drammatiche scene, ma poi, attraverso una certa lotta fra il Bene e il Male, l’Innocenza e la Cupidigia, il Divino e l’Infernale, tutti simbolicamente rappresentati, sfociava ogni tanto nelle più libere e grossolane forme della solita comicità dialettale. La Cantata, ovvero, “la Nascita del Verbo umanato e il vero lume fra le ombre”, aveva principalmente un suo proposito educativo: ma nel corso del tempo si allontanò sempre più dal testo della sua edizione originale, seriosa e risuonante di parole, sdrucciole, e in cui il solo personaggio di Razzullo aveva, in fondo, una sua uanità ed un suo carattere umoristico.
Nel 1698 l’autore Andrea Petrucci, che si celava sotto il nome accademico e professorale di “Dottore Casimiro Ruggiero Ugone” fece rappresentare per la prima volta la Cantata. Fin da quel tempo la sua opera classicheggiante, pur conservando sempre una certa dignità d’impostazione, offriva, proprio nella sua stessa architettura, la invitante possibilità di evadere dal testo; anche il Petrucci, in omaggio alla libertà, aveva usato senza risparmio e senza misura, il polimetro. E, perseguitato com’era da qualche retorica, quanto convenzionale figurazione, se ne serviva spesso per sbalordire gli spettatori. Ecco, ad esempio, un suo ripetuto distico: “Son dell’Erebo il prence invisibile, l’incomprensibile”.
Il “Convegno di Pluto” e gli altri prologhi alla Cantata
Avendo inoltre fatto precedere la Cantata da un “Convegno di Pluto” dove tutto verbalmente si complica con una serie intrecciata di aggettivi ed avverbi, coloro che in principio ebbero l’ingrato compito di rappresentarlo, finirono per dargli subito il bando. In codesto prologo compolottano e congiurano le così dette “Furie” chiamate da Pluto, loro signore, a convegno nell’Averno per l’annuncio del prodigioso evento: l’imminente nascita del Messia, secondo la profezia di Davide. I “diavoletti” Asmodeo, Astarotte e Belzebù, in maglione rosso e catene alle braccia, pettegoli e femminei, offrono la loro opera, ma Pluto preferisce il fido Belfagor, più serio e sfrontato degli altri, il quale si avvia subito alla ricerca della coppia “indegna” (Maria e Giuseppe) impegnandosi a sterminarla senza pietà. Abolito poi il prologo originale, ciascuno si preoccupò di sostituirlo a suo modo, convinto che non dovesse mai mancare alla vicenda un episodio iniziale che servisse subito a richiamare l’attenzione del pubblico: un episodio biblioco solenne, ausotre, a cui potesse seguire, come uno svago, la commediola, in massima parte divertente, della Cantata. Sui cartelloni cominciarono a comparire così i mirabolanti titoli dei nuovi prologhi: Adamo ed Eva, Sodoma e Gomorra, Sansone e Dalila, Giuditta e Oloferne, Caino e Abele. I direttori delle occasionali compagnie si emulavano e si superavano: il solo Pasquale Cestari ne aveva scritto ventuno.
La comparsa di Sarchiapone e il “rito delle noci”
A Maria Vergine, al vecchio Giuseppe, al biondo Gabriele Arcangelo, al venerando pastore Armenzio, a Cidonio e Benino suoi figli (il prio robusto e mattiniero, il secondo sparuto e dormiglione) a Ruscello “pescatore gentile” ed a Razzullo, infine, vagabondo napoletano, pavido per gli eventi ed affamato per destino, si aggiunse Sarchiapone, non meglio identificato e di cui si ignora l’atto di nascita. Era anche accaduto che i “diavoli” con i maglioni rossi e le maschere leonine in rilievo sulle corazze di stagno dorato, erano diventati frattanto una buona dozzina. Ma è meglio seguire la più interessante trasformazione: Razzullo, avventizio, in un censimento disposto da Cesare Augusto, si è smarrito per le campagne di Betlemme ed invano si dibatte tra la paura e l’appetito. Lo sciagurato scrivanello è distinto, porta il mantello di pelo, il cappello, gli scarpini con le fibbie di metallo. Sarchiapone è il nuovo venuto, diventato il suo indivisibile compagno, che si è fatta, invece, una redditizia ragione di vita con il racconto di uno scampato processo per omicidio alla Assise di Napoli, è un finto idiota: un po’ gobbo di natura, esagera a suo vantaggio l’imprefezione fisica; un po’ scilinguato, accentua il difetto della sua pronuncia, con la sicurezza d’interessare e di esilarare. Ma in quelle campagne non si incontra che una stanca e desolata coppia fuggiasca in cerca d’asilo e qualche diavolo, astuto trasformista. Sarchiapone non si rassegna ed apre ogni tanto il valigione che si trascina dietro a fatica, per compiere i suoi stupidissimi giochi di prestigio. E’ un personaggio davvero comico: elastico e saltellante, cammina in punta di piedi, con l’abito strettissimo a quadretti, il cilindro, un cravattone bianco che lo soffoca. Razzullo, poverino, vede, ascolta, tace e medita. Fedele (l’unico) alla tradizione, ripete scrupolosamente i difficoltosi polimetri napoletani che il Petrucci gli ha riservato, mentre tutti gli altri parlano l’idioma gentile. Del censimento non si parla più. Razzullo, più che mai affamato, ha bussato invano a tutte le porte; Ruscello, il pescatore gentile, lo accoglie nella sua barca, mai diavoli, per impedire che la sacra coppia passi da una riva all’altra, scatenano fulmini e saette; Cidonio lo arma di archi e frecce, ma la caccia è pericolosa a causa dei serpenti che Pluto scaraventa nella grotta dove riposano Maria e Giuseppe; Belzebù, mascherato da oste, lo assume come garzone, ma pretende che egli apra la porta della cantina con una chiave infuocata. Ormai tutte le speranze sono fallite. Ma Sarchiapone ha un’idea, ed ecco i due, a braccetto, percorrere la ribalta chiedendo l’elemosina. Sulla buca del suggeritore e fra le lampade (questo episodio fece entusiasmare una volta due spettatori di eccezione: Luigi Pirandello e Renato Simoni), cadono e rimbalzano così i soldini di rame che il pubblico lancia dai palchi, dalla platea e dal loggione. Razzullo esista, si china e cerca, ma l’altro, più furbo e lesto di lui, riesce subito a trovarli e a nasconderli negli scarpini, raccogliendo anche sigarette, datteri e noci che piovono da tutte le parti. Le noci, come è prescritto nell’aggiornata edizione dello spettacolo, non possono mai mancare: Sarchiapone, con una piroetta, deve schiacciarle con il cocuzzolo e, per carità, nessun colpo a vuoto, nessuno, sotto pena di una frenetica raffica di urla e fischi.
‘Ntuono d”e Cangiane, re della Cantata
Antonio De Pasquale, noto come ‘Ntuono d”e Cangiane, scaricante di porto e poi taverniere del vicolo dei Cangiani, aveva debuttato, giovanissimo, nella compagnia di Luigi Menzione al teatro San Ferdinando, nella parte di Uriel, ma emigrato in America il Menzione, lo sostituiva qualche anno dopo nella direzione della compagnia e nella interpretazione del Belzebù accanto a Salvatore Mauro, diavolo di qualità, durante il decennio 1880-90. Al teatrino Stella Cerere Antonio aveva avuto poi il suo vero battesimo: è interessante conoscere in quale maniera egli avesse appreso la suprema “arte” della “caduta”. Nei teatrucoli delle marionette, dove ogni anno si rappresentava la Cantata, era di obbligo una piccola ma non facile manovra di abilità: colui che reggeva i fili del diavolo di legno, sapeva tirarli così bene, al tempo giusto, quei fili, in un solo strappo, che la marionetta cadeva con la testa in giù e così si manteneva in equilibrio, immobile, le gambe in alto incrociate. ‘Ntuono, studia oggi e studia domani, s’era reso conto dell’abile manovra, l’aveva imitata e poi addirittura superata. Quando egli usciva dalle quinte in maglione fiammeggiante, tutto bracciali e grosse catene risuonanti, il pubblico, in delirio, lo salutava re della Cantata. Al cospetto della spada serpentina e dello scudo sfavillante di Gabriele Arcangelo che scendeva dal cielo a mezzo di unafune e per opera di un macchinista, il grosso Antonio, vinto, disfatto ed abbacinato, piombava d’un colpo con la testa sulle tavole, appena poggiato sul braccio destro, e rimaneva dieci minuti buoni con le gambe irrigidite in linea verticale. Il teatro, allora, si trasformava in una bolgia: otto, nove, dieci volte, egli era costretto a rialzarsi e a ricadere. Il biondo e ricciuto arcangelo gli toccava la corazza con la punta della sua spada e lui, rapidissimo, inesausto, infaticabile, precipitava di nuovo con un tonfo, sollevando, per la furia, nuvolette di polvere. Negli ultimi tempi, carico di gloria natalizia e di adipe, il povero Belzebù aveva dovuto limitarsi alla “mezza caduta”: una caduta ridotta, ecco, a cui tuttavia il fedelissimo pubblico tributava generosamente gli stessi applausi di prima. E quando quel bonaccione di diavolo, con il suo meritato necrologio sul giornale ed il mesto corteo dei suoi compagni di scena, attori come lui, per soli dieci giorni all’anno, era caduto davvero nel “regno dell’incomprensibile”, il suo nome rimase per un decennio, come un’insegna, in cima ai cartelloni della sua compagnia.
Altri interpreti della Cantata fino al 1954
Nei tempi felici per le scene indigene, anche Achille Majeroni e Michele Bozzo non disdegnarono di recitare la Cantata nei migliori teatri napoletani, mentre due nobili attori dialettali come Gennaro Pantalena e Giuseppe De Martino, l’uno da Razzullo e l’altro da Sarchiapone, richiamavano per l’insolito avvenimento gran folla di spettatori al Rossini e al Mercadante. Poi il “Vero lume fra le ombre” dovette rifugiarsi, per sempre, nell’unico teatro popolare superstite. Un teatro glorioso, legato alla storia della città, il San Ferdinando, dove l’ultimo impresario, Giuseppe Golia, ogni anno ne accrebbe sempre più i fasti. La Compagnia, diretta ora da Pasquale Cestari e Francesco Carmagnola, nel nuovo e spettacolare allestimento scenico, rifece ancora la Cantata, adattandola alle moderne esigenze del pubblico. E se le bombe tedesche non avessero distrutto quella sala, la secolare rappresentazione non si sarebbe, e forse per sempre, interrotta.
Roberto Minervini



SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
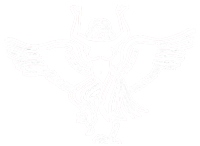


Devi essere loggato per commentare Login