Identità
UN ARTICOLO D’EPOCA / L’ultimo Tartaglia, il padre di Tina Pica, raccontato da Minervini



La foto in alto è tratta dalla rivista “LA LETTURA” del maggio 1930 (ma il testo è del 1928) a firma di Roberto Minervini, grande giornalista e autore dei primi del 900. L’articolo, modificato, fu poi incluso nel libro “I napoletani di Napoli” edito da Morano nel 1958, che è la versione che vi proponiamo. Racconta di Giuseppe Pica, l’ultimo “Don Anselmo Tartaglia” (in realtà nel ‘900 Tartaglia fu poi riportato in scena da Pasquale Esposito. In precedenza fu rappresentato per la prima volta verso la metà del Seicento dall’attore Carlo Merlino. Nel Settecento da Agostino Fiorilli. Nell’Ottocento dal padre di Tina Pica che ne fu sicuramente il più grande interprete in assoluto). Buona lettura…
L’ULTIMO TARTAGLIA
Giuseppe Pica, meglio noto come Don Anselmo Tartaglia, appena si accorse della mia presenza cercò di nascondere furtivamente, sul comò ingombro di nastri, guanti, immagini sacre, chicchere sbreccate e lumini da notte, un pezzetto di pane che in quel momento sbocconcellava, seduto in fondo alla camera, mentre Tina, sua figlia, allora attrice del San Ferdinando, in procinto di recarsi alle prove, si appuntava agli orecchi due grossi cerchi di similoro e si dava, dinanzi allo specchietto attaccato al muro, il rosso alle labbra. L’ultimo « Tartaglia » era un ometto basso e sparuto, intabarrato in un curioso pastrano, chiuso alla gola con uno spillo da balia.
Settantacinque anni di età; sessantaquattro di palcoscenico: dal teatrino del vicolo dei Sugherai, a piazza di Porto, dove esordì, poco più che decenne, al «casotto» del vicolo San Guido a Chiaia; dalla Partenope all’Arena napoletana; dai teatri della provincia al San Carlino. E poi, insieme con le ultime compagnie girovaghe, sempre più fuori del tempo, incapaci di sollecitare ancora le gioconde frenesie del loro publico, eccolo costretto a ramingare per campestri contrade, o sostare in sale minori, che intanto già si trasformavano e cominciavano a sostituire, con quelle cinematografiche di Harold Loyd, le avventure sempliciotte di “Pullicenella che torna dalli studi di Padova”.
Chi poteva infatti più folleggiari per gli sgambetti della “maschera” spaventata dalle lumache o perseguitata dagli spiriti? Alle guasconate, del guappo Cecereniello Sangodoce con la tuba bianca, i calzoni a campana e il prezzemolo all’orecchio? Ai terzetti con poco sale e poco pepe di Panecrazio Cocozziello, Asdrubale Barilotta e Zenobia Pappagallo?
Ma Don Anselmo non s’era lasciato seppellire definitivamente nel libro delle patri cose che furono: aveva soppresso il tricorno, è vero, la goletta, la parrucca con i riccioli, i calzoncini corti, le calze lunghe e gli scarpini con le fibbie, ma, di riffa o di raffa, non aveva perduta gran che: anche da solo, anche nei salotti borghesi, anche nelle feste popolari di beneficenza, riusciva decorosamente a mettere ogni giorno un piatto a tavola.
Si presentava, ora, alla lunga, come lui precisava: abito da sera, cilindro e occhiali, grossi occhiali cerchiati di nero, unico, tipico e tradizionale segno dell’esser suo nella commedia pulcinellesca di provenienza. Ma il giuoco e la tecnica di condurlo rimanevano gli stessi di quando si presentava alla corta: il “Tartaglia”, con quelle sue labbra che non stavano mai ferme un istante, non era un balbuziente da poco, uno qualunque, ma un finto sciagurato, capace di suscitare risate e ilarità, sostituendo comiche parole a quelle, non comiche, che avrebbe dovuto pronunciare. Digraziatissima lingua, la sua, ma egli la sfruttava accalorandosi per i suoi puntigliosi, imbrogliati, discorsetti. Dalle ‘a pasta e ‘o brodo, per dire Alla Patria il brando; Mimì, giucammo a scopa, per Mi giudica e Mi ascolta; E sabato vene ‘e vintotto ‘e giugno, per Si, sangue ne viene e vendetta giusta.
Si chiamavano, quei discorsetti, “declamazioni”. E la difficoltà di prepararle, le “declamazioni”, non era solo quella di trovare qualche espressione che si adattasse perfettamente, come suono, cadenza e analogia, alla frase giusta, ma qualcosa di divertente, di esilarante, di irresistibile, che si prestasse all’equivoco della ineffabile sostituzione. Pica insisteva su questa difficoltà e me lo spiegava con insistenza i motivi, quantunque io, già partecipe ed edotto, non facessi che dargli ragione, aggiungendo, a sostegno, dei suoi, i miei argomenti in proposito, tanto più che progettavo di scrivere un saggio sul trascurato Don Anselmo e ne conoscevo storia e peripezie.
La visita si prolungà più del previsto, perché lui, infervorato a chiarirmi quella tale difficoltà, volle poi mostrarmi a leggere, si confidò: “Ne ho fatto nottate! Povero cervello mio… La parola nun veneva, non veniva… Ma io niente, non andavo avanti finché non la trovavo, la parola. Ho scritto centinaia di “declamazioni”. Un editore voleva pubblicarmele, bontà sua, ma indovinate quanto mi offriva? Trenta lire. Voi capite? Centinaia di nottate per trenta lire”.
Erano d’argento, nell’anno di grazia 1928, ma sempre pochine, trenta lire.
Roberto Minervini
Rivista Le Lettere 1930
Napoletani di Napoli, 1958 (Morano Editore)
Si ringrazia Mariolina Cozzi per la preziosa collaborazione.



SulSud è un giornale on line nato dalla volontà di un collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
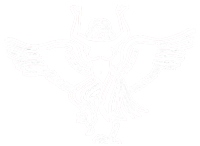

Devi essere loggato per commentare Login