Cultura
L’ANNIVERSARIO / 90 anni senza Vincenzo Gemito. Il racconto di un incontro con Roberto Bracco



Il pezzo che vi riportiamo è del marzo 1910 ed è tratto dal volume: “Tra Arte e Artisti” di Roberto Bracco, (editore Dottor Gennaro Giannini). Racconta del ritorno in scena di Vincenzo Gemito dopo 20 anni di isolamento.
Leggendo, or è qualche giorno, nel Mattino di Napoli, che Vincenzo Gemito era stato ricevuto dal Re d’Italia come 23 o 24 anni fa, ebbi per un istante l’impressione di essermi svegliato da un sonno di pochi minuti e d’aver sognato, nel brevissimo sonno, il lungo periodo di vita che, invece, ahimé, purtroppo avevo da allora veramente vissuto. Mi parve per un istante che questi 23 o 24 anni non fossero trascorsi che nelle mie confuse e vertiginose visioni di dormiente e mi parve d’aver visto tra l’altro, sognando, il Re Buono perire miseramente in una giornata di luce e di festa, vittima dell’audace efferatezza di un mostruoso assassino e il gagliardo scultore napoletano soccombere all’opera occulta di una occulta mano spietata e mutarsi in fantasma aggirantesi, irrequieto, taciturno e misterioso, tra le pareti di una cameretta squallida, inutilmente scrutato dagli sguardi acuti e ansiosi dello psichiatra.
E, appena svanita la dolce illusione che mi toglieva di dosso poco meno di un quarto di secolo, ho ricordato. Ho ricordato i bei tempi in cui un singolare fascino esercitava su me e su tutti i miei coetanei iniziati come me al giornalismo e alla letteratura, lo scultore mirabile, che già da parecchi anni, cedendo alla nostalgia del paese nativo, era tornato da Parigi, dove il grande Meissonnier gli aveva detto: tu sei un grande. E la mia memoria ha soprattutto, ripescati, nella morta gora dei ricordi lontani, i particolari della visita che, per zelo di neo-cronista e per commozione di ammiratore, io feci a Vincenzo Gemito dopo aver letto in un giornale – proprio come di recente mi è occorso – che egli era stato ricevuto dal Re d’Italia.
***
Fui mattiniero, quel giorno, e di buon’ora mi recai alla fonderia che lo scultore aveva fatta sorgere laggiù a Mergellina, tra la breve insenatura del mare e la gibbosa erta di Sant’Antonio. Quella fonderia sembrava un intimo e speciale laboratorietto che il Signore Iddio Onnipotente avesse affidato a Vincenzo Gemito, affinchè costui fabbricasse creature umane e moltiplicasse ciascuna di esse per conferir loro il divino privilegio della ubiquità. Si vedevano, lì, uscire a decine da massi incandescenti e mettersi allineati in attesa della lor destinazione: i Narcisi, gli Acquaioli, i Giuseppe Verdi, i Fortuny; e si sarebbe detto che poi Gemito serbasse, talvolta, per sé, qualcuna delle creature messe al mondo per conto del Signore, destinandola alle bisogne della fucina. Non era stato, forse, plasmato da lui il giovinotto che qul giorno, prima che lo scultore giungesse, mi fece gli onori di casa? Snello, bruno, nervoso, con un profilo energico che aveva tuttavia qualcosa di molto gentile, con certi occhi grandi e nerissimi che effondevano una sincera luce di vita intensa, egli aveva una impronta di bellezza modellata da un prfondo e fedele interpete dei più puri atteggiamenti estetici della natura.
Quel giovanotto si chiamava Celentano. Era già un artista di valore, ma si compiaceva di far l’operaio nella fucina di Vincenzo Gemito. “Qui dentro imparo – egli soleva affermare – a mettere anime nel bronzo come le mette il Padreterno nella carne viva”.
Celentano mi ricevette con festosa allegria. I suoi due o tre collaboratori erano intenti nella fucina: ma lui, quel giorno, ci badava poco e aveva una insolita aria festaiola. Si affrettò a mostrarmi la cassa che, reduce da Roma, ancora chiusa, conteneva “il pezzo di mezzo” in cera che aveva suscitato l’entusiasmo del Re e aveva procurato allo scultore la commissione definitiva di tutto il “servizio di gala” della tavola di Corte; e anche si affrettò a dirmi che quella mattina il professore sarebbe giunto tardi alla fonderia, perché senza dubbio si era lasciato vincere dal sonno.
– ‘o Prufessore ha pigliato suonno stammatina. Iersera, tornando da Roma, si sentiva stanco come se fosse venuto direttamente dalla Russia.
– Che vi raccontò iersera – gli domandai – che vi raccontò.
– Niente mi raccontò – rispose Celentano – proprio niente; ma era tutto contento e pazzariello e, a casa, volle svegliare la bambina e, dopo averla tempestata di baci, se la mise a cullare fra le braccia meglio di una balia.
***
E verso mezzogiorno vidi comparire di lontano lo scultore. Vidi cioé comparire, come portata da una vela di raggi solari più vividi di quelli che inondavano la piazzetta di Mergellina, una larga barba fluttuante nella quale pareva si rifuggiasse una colombella. Evidentemente, lo scultore continuava a espandere, nella tenerezza di babbo, la gioia del suo cuore d’artista e si deliziava, come la sera innanzi, nell’offrire in premio alle robuste braccia e alle mani sapienti il piccolo peso della sua bimba.
Gli andai incontro salutandolo con reverenza, baciai la bimba sorridente – che sulla soglia della fonderia, distaccatasi dalla barba paterna, prese la rincorsa per cacciarsi fra i Narcisi, gli Acquaioli, i Fortuny e i Giuseppe Verdi e per mettersi a conversare con loro, toccandone i nasi, i menti, gli orecchi – e subito lo interrogai sul risultato della sua gita a Roma.
– Se vogliamo parlare un poco – diss’egli – accompagnatemi. Sono aspettato dal commendatore!
Per lui il commendatore tout court era il commendator Pompeo Carafa che, occupando non ricordo più quale altra carica a Corte, abitava nella Reggia di Napoli e che, amico degli artisti e fervido apostolo dell’arte di Vincenzo Gemito, aveva da qualche tempo vagheggiata l’idea che questi eseguisse un “servizio di gala” per la tavola Reale.
Allontanatici dalla fonderia, camminavamo, Gemito e io, tra i filari degli alberi della Villa Comunale; ed egli, nonostante la fretta che aveva di vedere il commendatore, di tanto in tanto si fermava infervorato nella sua selvaggia eloquenza descrittiva. Modulava la voce con una varietà che era la immediata espressione sonora dei vari stati per i quali il suo animo aveva dovuto passare e raccontava, anche con gli occhi, con le braccia, con le gambe, con la barba, col cappello, or curvandosi e dando al corpo una linea di umiltà a guida di un povero mendicante, or drizzando in atto di alterigia signorile, ora raggomitolandosi come un gatto, or balzando come una palla caoutchouc, E io lo guardavo e lo ascoltavo muto e compreso d’ammirazione, meravigliandomi più che mai di quella strana fusione di immutabile popolano partenopeo, di scultore, di oratore, di filosofo incosciente e di spontaneo attore drammatico.
Egli mi fece, anzitutto, “assistere” con l’immaginazione, a un sontuoso banchetto Reale, che lui stesso immaginava, raffigurandosi già la sua opera compiuta sulla sfolgorante mensa del Re. Ed io ben vidi, nella sua descrizione, tra teste di ministri, di generali, di diplomatici, l’immenso gruppo centrale del servizio d’argento e gli squisiti pezzi minori, i candelabri, le zuppiere, i vassoi, le fruttiere, le saliere e i gingilli ornamentali sparsi sulla tavola e vidi, rilevati da una magistrale cesellatura, i putti follegianti, le vigili sirene incantatrici e non so quante altre voluttuose o austere o gioconde figure simboleggianti i mari, i fiumi, i monti e le città d’Italia.
– Tutta questa Italia – mi diceva Gemito – deve partecipare al banchetto del re; deve stare con lui quando lui si riposa e pranza; e tutti i convintati, i ministri, i generali, i diplomatici, i rappresentanti di ogni parte del mondo, debbono vedere che l’Italia festeggia anche a tavola il suo sovrano!
E raccontava, raccontava…
A Roma, entrando nel Quirinale, aveva avuto come un’impressione di paura. L’etichetta di quel vasto ambiente era stata il suo martirio.
– Io posso fare il diavolo a quattro in un bugigattolo pieno di mobili sciancati senza mai urtarne nessuno: e invece nella vastità del Quirinale mi pareva sempre di intoppare in qualche cosa. E poi mi sentivo ridicolo. Se anche camminavo soltanto credevo di fare una cattiva figura e d’essere un maleducato. Avrei voluto mutarmi in un Giano per non voltare le spalle nemmeno ai muri!
Tutti quei cortili, tutte quelle scalinate, tutte quelle porte, tutti quei corridoi, tutte quelle sale d’aspetto, lo disorientavano producendo in lui un confusionismo topografico più imbarazzante di quello che lo aveva maledettamente esasperato quando giunse a Parigi. E un altro tormento era per lui la gerarchia delle autorevoli persone con cui doveva parlare, portava in saccoccia una carta scritta che di tanto in tanto consultava. E in compagnia di quella carta egli passò tre intere giornate al Quirinale. Andava da Erode a Pilato, percorreva dei chilometri, si stancava, si metteva a dormicchiare in un cantuccio, cadeva in languore, sbadigliava, aveva sete, aveva fame, aveva voglia di fumare, aveva voglia di uscire all’aria aperta e, soprattutto, aveva voglia di tornarsene a Napoli, dove l’aspettava la statua di Carlo V, ch’egli temeva di trovare disseccata e forse anche spaccata come un popone qualunque. I suoi avversari naturali erano i camierieri, gli staffieri, gli uscieri. Vestivano riccamente, come gran signuori, e lui sentiva di sembrare, ai loro occhi, addirittura l’ultimo dei pezzenti. E avevano poi un’aria grave, solenne, indifferente, e gli rivolgevano la parola a malincuore, con una brutta faccia severa.
– Eh!… è inutile caro lei. Avrà un bell’aspettare! Il marchese è occupato. Se ne vada, se ne vada.
Infilava un corridoio, scendeva una scaletta, saliva uno scalone, attraversava una sala, si ficcava in un salotto e trovava un’altra livrea.
– Cosa desidera lei?
– Dovrei parlare col conte
– Il conte è occupatissimo, adesso. Ma, forse, tra un paio d’ore…
– Va bene, aspetterò. Ma, caso mai lo vedete, ditegli che c’è fuori quel napoletano con la barba.
Gemito pensava che della sua barba il cameriere si sarebbe ricordato più facilmente del suo nome. E fu appunto annunziato nella sua qualità di napoletano con la barba quando il commendatore Rattazzi, direttore generale della Real Casa, gli concesse di riceverlo.
Il commendator Rattazzi, che già aveva visto il pezzo di mezzo in cera, gli espresse il suo entusiasmo ma con frasi misurate e prudenti. Indi, lo lasciò solo per un’altra oretta, che a Gemito parve lunga come non mai gli era parsa un’ora della sua vita e tornando, secco secco, gli domandò.
– Dunque, quanto costerebbe quel coso lì?
Il cameriere gli aveva raccomandato: “due parole e via!”. Gemito, allora, interrogò timidamente:
– Posso parlare si o no?
– Parli, parli pure
– Ma io debbo parlare a lungo. Perciò quando vi sarete stancato di sentirmi mi direte: basta!
– L’ascolto.
Gemito non accennò neanche vagamente al prezzo di “quel coso lì” ma raccontò la sua vita al direttore generale della Real Casa. E, dopo aver descritto le peripezie della sua fancillezza e della sua adolescenza, tutto sudato per lo sforzo di parlare davanti a “una autorità” concluse:
– Insomma, io ero uno scugnizzo, un piccolo lazzarone sperduto, e mi hanno fatto credere che sono uno scultore. Io potrei vivere, ancora, con cinque soldi al giorno, potrei “mangiare asciutto”, potrei bevere nient’altro che acqua. Ma sono uno scultore e spendo più di quanto guadagno. Ho la condanna di due o tremila lire di debiti ogni anno, perché non si può fare lo scultore senza danari. C’è una sproporzione. Oppure c’è un equivoco. Forse, non è vero che sono uno scultore. Ma tutti mi dicono che lo sono, e qui sta tutto il male!”.
Il commendatore Rattazzi non si mosse, non aggiunse motto; ma Gemito come per una corrente magnetica sentiva che quell’uomo freddo, compassato, nobilmente austero nell’aspetto e nei gesti, si era commosso.
– I suoi occhi, che m’erano sembrati quelli di un automa – soggiungeva Vincenzo Gemito, terminandomi il bozzetto di quell’episodio – luccicavano ora come se li avessi lavati col limone.
Il giorno dopo lo scultore fu ricevuto da Re Umberto. Innanzi al “pezzo di mezzo” in cera, Re Umberto, ritto, circondato di luce, in un amplissimo salone dorato, parlò a Gemito.
– Faccia quel che vuole, purché faccia un’opera degna dell’arte italiana, purché faccia un’opera di cui non ci sia l’eguale in Europa. Essa deve esser tale che possa un giorno testimoniare del più alto grado di perfezione artistica dei nostri tempi e del nostro paese.
Vincenzo Gemito, ricordando la persona e le parole del Re, aveva la voce velata, e i suoi sguardi tremolavano in una dolcezza di riconoscenza infantile. E io trovo ancora oggi, come stampato in un libro, nella mia memoria, esattissimamente, il suo vibrante epiloghetto:
– Era un Re. Si vedeva. Si sentiva. Parlava come tutti gli altri uomini, eppure pareva il migliore di tutti. Il suo gesto era semplice ma era bello. Movendo un braccio pareva si rivolgesse non a me, ma a tutto il suo popolo. Era un Re. Ordinava una grande opera artistica italiana… Ora capisco l’esistenza di un Re”.
Chiacchierando così eravamo usciti dalla Villa Comunale, avevamo attraversato la folla di via Chiaia e avevamo percorso il marciapiede rasentando la cancellata del giardino della Reggia. Io, dopo aver stretto la mano allo scultore giubilante, che era aspettato lì da Pompeo Carafa, stavo per allontanarmi: ma il “napoletano con la barba” mi richiamò d’urgenza.
– Un momento… voglio dirvi un’altra cosa. Quando uscii dal salone dorato, dove avevo ricevuta la commissione del Re, il mio cervello, certamente, era di traverso. Se qualcuno mi avesse domandato come si chiama questo re, Io avrei risposto: “Francesco I”. E se qualcuno m’avesse domandato “come ti chiami tu?” io avrei risposto. “Benvenuto Cellini”.
Qui il napoletano con la barba sorrise e in gran fretta infilò il cancello del giardino Reale.
***
Ora, dopo tanti tristi anni, il grande scultore è tornato al Quirinale. E gli sono stati offerti uno spettacolo d’onore in un teatro di Roma e un banchetto da una schiera di artisti.
Gemito si sarà domandato:
– Perché tutto questo? Che accade intorno a me? Sono io forse oggi un uomo diverso da quello che ero nella mia cameretta silenziosa quando la gente mi credeva infermo? Quale era la mia infermità? Che avrei dovuto fare per sembrar sano come mi sentivo? Avrei dovuto lavorare? E non lavoravo, forse, io sempre con la mia mente? E non facevo io, forse, anche lo scultore e il disegnatore, per conto mio, cercando di perfezionarmi?
Io ho veduti, difatti, alcuni disegni da lui eseguiti durante la sua volontaria misteriosa prigionia. Egli soleva, talvolta, disegnare sul medesimo pezzo di carta, sul medesimo pezzo di legno, due, tre, quattro volte, il medesimo profilo. E preferiva il profilo di una donna: il profilo di colei che gli fu umile e gaia compagna nei luminosi giorni della incipiente gloria e che gli è poi stata, sino a poco tempo fa, paziente devota infaticabile infermiere. Egli l’aveva conosciuta come modella. (il visino di quella bambina che frettolosamente portava in giro sotto il sole di Posillipo e Mergellina, il suo scialletto sdrucito, le sue scarpacce scalcagnate e i suoi meravigliosi capelli tizianeschi, era d’una delicatezza incantevole nella serena mestizia diffusa dai grandi occhi estatici). Aveva per nomignolo Cusarella, piccola cosa. E Gemito se ne invaghì e la Volle sposare, e non se ne distaccò mai. Disegnando il profilo di lei, nella cameretta silenziosa, egli… perfezionsava la sua arte mentre la scienza psichiatrica inutilmente sorvegliava e scrutava. Il visino di Cusarella, moltiplicato come il segno di un’eco, resterà, immoto e indelebile, a confondere la scienza e a documentare la tenacia di un’arte su cui una valanga passò senza poterla travolgere.
Ma lei – Cusarella – è morta.
Roberto Bracco
Nella foto Mancini, Gemito e Casciaro a Villa Lucia.



Giornalista professionista dal 1997, ha vissuto e lavorato 20 anni a Roma. Nel 2014 è tornata a Napoli dove ha fondato con Drusiana Vetrano e altri “Identità insorgenti” quotidiano che ha diretto per 7 anni. Nel 2021 è tra i fondatori del portale SulSud. Rivendica orgogliosamente le sue radici suddiste: è figlia di Antonio Parlato che al Sud ha dedicato la sua intera esistenza, di cui spera di aver raccolto degnamente l’eredità culturale.
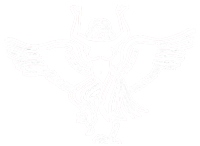





Devi essere loggato per commentare Login